Semplificazione UE o sacrificio della scienza?
 Il contributo che pubblichiamo oggi, a firma di Maurizio Ferri (Coordinatore scientifico SIMeVeP), accende i riflettori su una metamorfosi preoccupante in atto nelle istituzioni europee. Sotto il vessillo della cosiddetta Agenda di Semplificazione e del Pacchetto Omnibus 2025 della Commissione, si sta consumando un passaggio critico che rischia di vedere la società civile e la sanità pubblica relegate in secondo piano rispetto alle logiche di riduzione dei costi per le imprese declamate nei nuovi provvedimenti. Riteniamo vitale seguire questo sviluppo normativo per alcuni elementi richiamati nel documento, in primis il pericolo che le decisioni tecniche vengano sottratte al rigore scientifico per favorire procedure più snelle ma meno sicure. Come garanti della salute secondo l’approccio One Health, i medici veterinari non possono restare spettatori di una riforma che incide sulla trasparenza e sulla qualità dei controlli.
Il contributo che pubblichiamo oggi, a firma di Maurizio Ferri (Coordinatore scientifico SIMeVeP), accende i riflettori su una metamorfosi preoccupante in atto nelle istituzioni europee. Sotto il vessillo della cosiddetta Agenda di Semplificazione e del Pacchetto Omnibus 2025 della Commissione, si sta consumando un passaggio critico che rischia di vedere la società civile e la sanità pubblica relegate in secondo piano rispetto alle logiche di riduzione dei costi per le imprese declamate nei nuovi provvedimenti. Riteniamo vitale seguire questo sviluppo normativo per alcuni elementi richiamati nel documento, in primis il pericolo che le decisioni tecniche vengano sottratte al rigore scientifico per favorire procedure più snelle ma meno sicure. Come garanti della salute secondo l’approccio One Health, i medici veterinari non possono restare spettatori di una riforma che incide sulla trasparenza e sulla qualità dei controlli.
Il Pacchetto Omnibus viene criticato per la mancanza di dibattito pubblico, operando in una sorta di oscurità delle procedure tecniche che potrebbe indebolire i pilastri della sicurezza alimentare e della protezione dell’ambiente.
Seguire l’evoluzione di queste direttive non è solo un esercizio di aggiornamento normativo, ma risponde al primato dell’evidenza scientifica che significa difendere la nostra funzione sociale e la salute dei cittadini.
 Negli ultimi anni i formaggi a latte crudo sono tornati protagonisti sulle tavole e nel dibattito sulla sicurezza alimentare. Questa vasta gamma di prodotti artigianali, spesso tipici di specifici contesti rurali, sono apprezzati per i loro supposti valori di “naturalità” e tradizione. Tuttavia, il loro consumo può esporre i consumatori a pericoli sanitari, legati alla possibile contaminazione con Escherichia coli produttori di shigatossine (STEC), responsabili di gravi forme di tossinfezione alimentare nell’uomo.
Negli ultimi anni i formaggi a latte crudo sono tornati protagonisti sulle tavole e nel dibattito sulla sicurezza alimentare. Questa vasta gamma di prodotti artigianali, spesso tipici di specifici contesti rurali, sono apprezzati per i loro supposti valori di “naturalità” e tradizione. Tuttavia, il loro consumo può esporre i consumatori a pericoli sanitari, legati alla possibile contaminazione con Escherichia coli produttori di shigatossine (STEC), responsabili di gravi forme di tossinfezione alimentare nell’uomo. Aldo Grasselli, Segretario Nazionale SIVeMP, Antonio Sorice, Presidente SIMeVeP, Maurizio Ferri, Delegato italiano in UEVH, sezione di FVE sono intervenuti ieri a “
Aldo Grasselli, Segretario Nazionale SIVeMP, Antonio Sorice, Presidente SIMeVeP, Maurizio Ferri, Delegato italiano in UEVH, sezione di FVE sono intervenuti ieri a “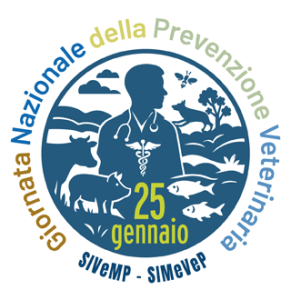 In occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria SIMeVeP e SIVeMP, in collaborazione con FVM e FESPA, hanno organizzato delle iniziative in tutta Italia per raccontare le attività di prevenzione, tutela e controllo dei Medici Veterinari del SSN.
In occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria SIMeVeP e SIVeMP, in collaborazione con FVM e FESPA, hanno organizzato delle iniziative in tutta Italia per raccontare le attività di prevenzione, tutela e controllo dei Medici Veterinari del SSN.


























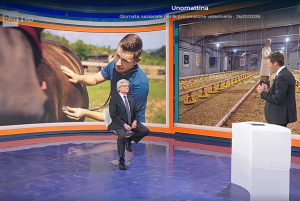 Aldo Grasselli è intervenuto ieri in diretta alla trasmissione Unomattina in onda su Rai1 con la conduzione di Massimiliano Ossini per parlare di veterinaria preventiva e del ruolo dei Medici veterinari nella salute pubblica, in occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria
Aldo Grasselli è intervenuto ieri in diretta alla trasmissione Unomattina in onda su Rai1 con la conduzione di Massimiliano Ossini per parlare di veterinaria preventiva e del ruolo dei Medici veterinari nella salute pubblica, in occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria Il pacchetto Omnibus ‘Alimenti e Mangimi’ (proposta di Regolamento) presentato della Commissione europea a Dicembre 2025, in discussione al Parlamento Europeo e Consiglio e la cui approvazione finale è prevista entro la metà del 2026, introduce cambiamenti significativi per ridurre gli oneri amministrativi e modernizzare le procedure. In sostanza raggruppa in un unico testo norme che prima erano sparse in decine di direttive e regolamenti diversi.
Il pacchetto Omnibus ‘Alimenti e Mangimi’ (proposta di Regolamento) presentato della Commissione europea a Dicembre 2025, in discussione al Parlamento Europeo e Consiglio e la cui approvazione finale è prevista entro la metà del 2026, introduce cambiamenti significativi per ridurre gli oneri amministrativi e modernizzare le procedure. In sostanza raggruppa in un unico testo norme che prima erano sparse in decine di direttive e regolamenti diversi. In occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria – istituita con la Legge 1° aprile 2025, n. 49 – che si celebrerà il 25 gennaio, SIVeMP e SIMeVeP hanno realizzato un logo per rappresentare simbolicamente il ruolo fondamentale e strategico dei Medici Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.
In occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria – istituita con la Legge 1° aprile 2025, n. 49 – che si celebrerà il 25 gennaio, SIVeMP e SIMeVeP hanno realizzato un logo per rappresentare simbolicamente il ruolo fondamentale e strategico dei Medici Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale. FVE, Federazione dei Veterinari Europei invita a partecipare a un webinar congiunto con European Dairy Association (EDA), European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) e Humane World for Animals Europe su: “Sicurezza degli alimenti e dei mangimi in Europa – contributi veterinari alla sicurezza alimentare e alla lotta contro la disinformazione nella preparazione alle crisi” che si terrà venerdì 16 gennaio alle 11:00
FVE, Federazione dei Veterinari Europei invita a partecipare a un webinar congiunto con European Dairy Association (EDA), European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) e Humane World for Animals Europe su: “Sicurezza degli alimenti e dei mangimi in Europa – contributi veterinari alla sicurezza alimentare e alla lotta contro la disinformazione nella preparazione alle crisi” che si terrà venerdì 16 gennaio alle 11:00
 Striature bianche sul petto del pollo, carni dure e accumulo di grasso non sono solo un difetto estetico: riflettono la pressione degli allevamenti intensivi, lo stress metabolico degli animali e un rapido accrescimento selezionato geneticamente. A fare chiarezza sull’argomento, in un’intervista a Voce della Sanità, è Maria Grazia Cofelice, Dirigente Veterinario del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale,
Striature bianche sul petto del pollo, carni dure e accumulo di grasso non sono solo un difetto estetico: riflettono la pressione degli allevamenti intensivi, lo stress metabolico degli animali e un rapido accrescimento selezionato geneticamente. A fare chiarezza sull’argomento, in un’intervista a Voce della Sanità, è Maria Grazia Cofelice, Dirigente Veterinario del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale,