Utilizzo di insetti nell’alimentazione dei ruminanti: caratteristiche delle fermentazioni ruminali
 L’alimentazione dei ruminanti è sempre al centro dell’attenzione e degli studi da parte degli organi di Ricerca, e la necessità di trovare fonti proteiche alternative è quanto più importante dato il particolare momento storico che tutti viviamo. Come già discusso, il consumo di risorse e l’impatto ambientale della loro produzione restano un problema quotidiano, soprattutto quando si parla di alimentazione dei ruminanti e degli animali da pascolo. Ecco quindi una nuova ricerca che mostra come l’utilizzo di fonti proteiche alternative possa rivelarsi una soluzione efficace al problema. Vediamolo nel dettaglio.
L’alimentazione dei ruminanti è sempre al centro dell’attenzione e degli studi da parte degli organi di Ricerca, e la necessità di trovare fonti proteiche alternative è quanto più importante dato il particolare momento storico che tutti viviamo. Come già discusso, il consumo di risorse e l’impatto ambientale della loro produzione restano un problema quotidiano, soprattutto quando si parla di alimentazione dei ruminanti e degli animali da pascolo. Ecco quindi una nuova ricerca che mostra come l’utilizzo di fonti proteiche alternative possa rivelarsi una soluzione efficace al problema. Vediamolo nel dettaglio.
L’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, Saint-Genès-Champanelle – France), ha sperimentato l’utilizzo di otto differenti farine di insetto (alcune delle quali mai state testate prima nell’alimentazione dei ruminanti o dei monogastrici), come potenziali fonti proteiche e lipidiche per la nutrizione di ruminanti.
Al fine di valutare al meglio la loro efficacia e idoneità da un punto di vista nutrizionale, queste farine sono state confrontate con tre farine di origine vegetale (farina di soia, di girasole e di colza, le più utilizzate nel settore) e con la farina di pesce, utilizzata come fonte proteica di origine animale di riferimento. Le otto specie di insetto testate sono state: Acheta domesticus L.; Alphitobius diaperinus Panzer; Blatta lateralis Walker; Grylloides sigillatus Walker; Gryllus bimaculatus De Geer; Hermetia illucens L.; Musca domestica L. e Tenebrio molitor L.
L’analisi chimico-bromatologica delle farine di insetto ha evidenziato un contenuto di proteina grezza paragonabile a quello delle farine vegetali, mentre il contenuto di estratto etereo è risultato di gran lunga superiore. Per tale motivo, le farine di insetto intere possono rappresentare anche un’ottima fonte lipidica o energetica, alternativa agli oli vegetali spesso utilizzati per aumentare la densità energetica delle diete o per migliorare il profilo acidico dei prodotti di origine animale, quali latte o carne.
Quest’ultimo risulta un aspetto particolarmente interessante, in quanto la maggior parte delle specie di insetto analizzate ha mantenuto, a seguito dei processi di bioidrogenazione, elevate concentrazioni di acidi grassi insaturi a livello ruminale, soprattutto acido linoleico (noto per avere effetti positivi sulla salute umana).
Con l’utilizzo delle farine di insetto si è osservata una produzione di gas (soprattutto metano) e acidi grassi volatili notevolmente inferiore rispetto a quanto verificatosi con gli altri alimenti convenzionali testati. Questo risultato è stato spiegato dagli autori dello studio come possibile conseguenza dell’elevato contenuto di proteina grezza ed estratto etereo delle farine di insetto, in quanto le proteine sono note per esercitare un effetto tampone (abbassano il livello di acidità), mentre un alto contenuto di lipidi può portare alla parziale inibizione della microflora metanigena ruminale e alla diminuzione della digeribilità dei carboidrati.
Infatti, anche la digeribilità totale dell’alimento è risultata inferiore per le farine di insetto rispetto alle farine vegetali e alla farina di pesce. Per tale esito, è necessario considerare anche la possibile influenza della chitina, un polisaccaride naturalmente presente nell’esoscheletro degli insetti e dei crostacei che non viene degradato dai microorganismi ruminali. Infine, le farine di insetto (ad eccezione di Blatta lateralis) risultano determinare una produzione inferiore di ammoniaca all’interno del rumine, rispetto agli altri alimenti convenzionali testati.
Ciò indicherebbe una minore degradazione delle proteine a livello ruminale, consentendo potenzialmente un loro maggior utilizzo a livello intestinale e rendendole di conseguenza più facilmente utilizzabili dall’animale. Alla luce di quanto riportato, gli autori di questo studio concludono che, da un punto di vista nutrizionale, le farine di insetto potrebbero essere potenzialmente impiegate come sostituti di fonti proteiche ed energetiche tradizionalmente utilizzate nelle diete dei ruminanti.
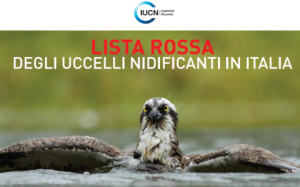 I dati aggiornati al 2021 fanno seguito alla valutazione del 2012
I dati aggiornati al 2021 fanno seguito alla valutazione del 2012 I nanomateriali sono materiali naturali, derivati o fabbricati contenenti particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, con almeno una delle dimensioni compresa tra 1 e 100 nanometri.
I nanomateriali sono materiali naturali, derivati o fabbricati contenenti particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, con almeno una delle dimensioni compresa tra 1 e 100 nanometri. Il D. Lgs. 27/2021 ha suscitato non poche riflessioni, sin dalla sua entrata in vigore, in coloro che sono chiamati ad applicarlo su versanti diversi.
Il D. Lgs. 27/2021 ha suscitato non poche riflessioni, sin dalla sua entrata in vigore, in coloro che sono chiamati ad applicarlo su versanti diversi. Anticorpi monoclonali, sviluppati in IZS, permetteranno una più efficiente diagnosi di una malattia virale che colpisce prevalentemente i cervi, ma che può attaccare anche i bovini danneggiando la produzione di latte
Anticorpi monoclonali, sviluppati in IZS, permetteranno una più efficiente diagnosi di una malattia virale che colpisce prevalentemente i cervi, ma che può attaccare anche i bovini danneggiando la produzione di latte L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato, nell’ambito dei Rapporti ISTISAN, il rapporto “Sorveglianza delle zanzare in Italia” a cura di Marco Di Luca del Dipartimento Malattie Infettive del ISS.
L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato, nell’ambito dei Rapporti ISTISAN, il rapporto “Sorveglianza delle zanzare in Italia” a cura di Marco Di Luca del Dipartimento Malattie Infettive del ISS. Il personale della Pubblica Amministrazione, fra cui rientrano i medici veterinari di sanità pubblica, deve essere in grado di applicare la normativa effettivamente in vigore specie per quanto riguarda le competenze sanzionatorie, ma per norme succedutesi nel tempo e sullo stesso argomento si possono registrare elementi di ambiguità, se non di vera e propria incompatibilità.
Il personale della Pubblica Amministrazione, fra cui rientrano i medici veterinari di sanità pubblica, deve essere in grado di applicare la normativa effettivamente in vigore specie per quanto riguarda le competenze sanzionatorie, ma per norme succedutesi nel tempo e sullo stesso argomento si possono registrare elementi di ambiguità, se non di vera e propria incompatibilità. Le nitrosammine (o più formalmente N-Nitrosammine) sono composti chimici che possono formarsi negli alimenti a seguito della preparazione e trasformazione di questi ultimi. Tali sostanze sono state rilevate in svariati tipi di prodotti alimentari, quali prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura, pesce trasformato, cacao, birra e altre bevande alcoliche. Le nitrosammine possono anche essere presenti in diversi altri alimenti, come la carne cotta, gli ortaggi trasformati, i cereali, i prodotti lattiero-caseari oppure in alimenti fermentati, sottaceto e speziati. Alcune nitrosammine sono genotossiche (possono danneggiare il DNA) e cancerogene (possono causare il cancro). Il progetto di parere dell’EFSA valuta i rischi per la salute pubblica correlati alla presenza di nitrosammine negli alimenti.
Le nitrosammine (o più formalmente N-Nitrosammine) sono composti chimici che possono formarsi negli alimenti a seguito della preparazione e trasformazione di questi ultimi. Tali sostanze sono state rilevate in svariati tipi di prodotti alimentari, quali prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura, pesce trasformato, cacao, birra e altre bevande alcoliche. Le nitrosammine possono anche essere presenti in diversi altri alimenti, come la carne cotta, gli ortaggi trasformati, i cereali, i prodotti lattiero-caseari oppure in alimenti fermentati, sottaceto e speziati. Alcune nitrosammine sono genotossiche (possono danneggiare il DNA) e cancerogene (possono causare il cancro). Il progetto di parere dell’EFSA valuta i rischi per la salute pubblica correlati alla presenza di nitrosammine negli alimenti. E’ stato presentato oggi il One Health Award, una una tre giorni di dibattiti, approfondimenti e riflessioni con scienziati, divulgatori, opinion maker e giornalisti che interagiranno tra loro e con l’opinione pubblica, a Teramo dal 14 al 16 ottobre, nel corso di incontri in programma al Teatro Comunale e all’Università degli Studi di Teramo.
E’ stato presentato oggi il One Health Award, una una tre giorni di dibattiti, approfondimenti e riflessioni con scienziati, divulgatori, opinion maker e giornalisti che interagiranno tra loro e con l’opinione pubblica, a Teramo dal 14 al 16 ottobre, nel corso di incontri in programma al Teatro Comunale e all’Università degli Studi di Teramo.