 Si terrà il 26 marzo a Roma, presso il Ministero della Salute a via Ribotta, il Convegno Nazionale, accreditato ECM, Veterinaria, Ambiente e Cambiamenti Climatici organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP.
Si terrà il 26 marzo a Roma, presso il Ministero della Salute a via Ribotta, il Convegno Nazionale, accreditato ECM, Veterinaria, Ambiente e Cambiamenti Climatici organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP.
I cambiamenti climatici sono una delle sfide globali più rilevanti, come evidenziato dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (dicembre 2023). Eventi climatici estremi e aumento delle temperature influenzeranno sempre più le realtà produttive, in partico-lare in Italia e nei Paesi del Mediterraneo, che ne subiranno gli effetti precocemente per le loro caratteristiche orografiche.
Tutto questo sta trasformando rapidamente gli ecosistemi creando problemi per la salute animale, con conseguenze per la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la biodiversità. Inoltre, l’innalzamento delle temperature e la maggior frequenza di eventi naturali catastrofici stanno favorendo l’insorgenza e la diffusione di malattie infettive, in particolare trasmesse da vettori (arbovirosi).
I mutamenti ambientali si riflettono su tutti gli ecosistemi. In questo scenario i medici veterinari, deputati alla tutela della salute animale, giocano un ruolo chiave nell’affrontare queste complesse sfide che coinvolgono salute umana, animale e ambientale, attraverso un approccio One Health.
Gli animali emettono naturalmente gas serra (almeno il 14,5% delle emissioni di gas serra indotte dall’uomo proviene dalla produzione animale, secondo le stime FAO), ma quelli malati o morenti, così come quelli che non producono in modo efficiente, aumentano l’impronta di carbonio del sistema produttivo, oltre a comportare uno spreco di risorse a causa degli interventi clinico-terapeutici e di controllo delle malattie (vaccina-zioni, abbattimento e gestione delle carcasse). Per questo la salute animale deve essere parte integrante delle strategie di contrasto ai cambiamenti climatici.
Altra problematica emergente è rappresentata da nano e microplastiche (NMPs) e PFAS (forever chemicals), che costituiscono oggi un preoccupante e diffuso problema ambientale. Sono infatti in grado di inquinare diversi ecosistemi, interessando la catena alimentare fino alla tavola del consumatore, e sollevando gravi preoccupazioni per la salute umana, con possibili impatti su assimilazione di nutrienti, infiammazioni e alterazioni ormonali. La riduzione di questi inquinanti richiede un approccio multifattoriale, basato su innovazione, economia circolare, regolamentazione e sensibilizzazione.
In tale contesto le attività di formazione, associate al potenziamento dei Servizi, risultano essenziali.
ANCORA DISPONIBILI POSTI COME UDITORI.
DAL 13 FEBBRAIO IL CORSO HA GIÀ RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI CON DIRITTO AI CREDITI ECM.
LE NUOVE ISCRIZIONI SARANNO INSERITE IN LISTA DI ATTESA.
IN CASO DI CANCELLAZIONI, GLI INTERESSATI SARANNO TEMPESTIVAMENTE AVVISATI E SI PROCEDERA’ ALLO SCORRIMENTO DELLA LISTA D’ATTESA IN ORDINE DI ISCRIZIONE.
GLI ISCRITTI CHE RIMARRANO ESCLUSI DAI CREDITI ECM POTRANNO PARTECIPARE COME UDITORI E RICEVERANNO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Locandina e programma del Convegno
Scheda di iscrizione
 Il contributo che pubblichiamo oggi, a firma di Maurizio Ferri (Coordinatore scientifico SIMeVeP), accende i riflettori su una metamorfosi preoccupante in atto nelle istituzioni europee. Sotto il vessillo della cosiddetta Agenda di Semplificazione e del Pacchetto Omnibus 2025 della Commissione, si sta consumando un passaggio critico che rischia di vedere la società civile e la sanità pubblica relegate in secondo piano rispetto alle logiche di riduzione dei costi per le imprese declamate nei nuovi provvedimenti. Riteniamo vitale seguire questo sviluppo normativo per alcuni elementi richiamati nel documento, in primis il pericolo che le decisioni tecniche vengano sottratte al rigore scientifico per favorire procedure più snelle ma meno sicure. Come garanti della salute secondo l’approccio One Health, i medici veterinari non possono restare spettatori di una riforma che incide sulla trasparenza e sulla qualità dei controlli.
Il contributo che pubblichiamo oggi, a firma di Maurizio Ferri (Coordinatore scientifico SIMeVeP), accende i riflettori su una metamorfosi preoccupante in atto nelle istituzioni europee. Sotto il vessillo della cosiddetta Agenda di Semplificazione e del Pacchetto Omnibus 2025 della Commissione, si sta consumando un passaggio critico che rischia di vedere la società civile e la sanità pubblica relegate in secondo piano rispetto alle logiche di riduzione dei costi per le imprese declamate nei nuovi provvedimenti. Riteniamo vitale seguire questo sviluppo normativo per alcuni elementi richiamati nel documento, in primis il pericolo che le decisioni tecniche vengano sottratte al rigore scientifico per favorire procedure più snelle ma meno sicure. Come garanti della salute secondo l’approccio One Health, i medici veterinari non possono restare spettatori di una riforma che incide sulla trasparenza e sulla qualità dei controlli. Si terrà il 5 e 6 marzo p.v. il corso dal titolo “IL LUPO TRA CONVIVENZA, TERRITORIO E GESTIONE, i ruoli del Medico Veterinario pubblico e degli altri enti nella verifica dei danni da fauna selvatica tra aspetti istituzionali e medico legali ”. Il corso, patrocinato dalla SIMeVeP, ha ottenuto 23 crediti.
Si terrà il 5 e 6 marzo p.v. il corso dal titolo “IL LUPO TRA CONVIVENZA, TERRITORIO E GESTIONE, i ruoli del Medico Veterinario pubblico e degli altri enti nella verifica dei danni da fauna selvatica tra aspetti istituzionali e medico legali ”. Il corso, patrocinato dalla SIMeVeP, ha ottenuto 23 crediti. Si terrà il 26 marzo a Roma, presso il Ministero della Salute a via Ribotta, il Convegno Nazionale, accreditato ECM, Veterinaria, Ambiente e Cambiamenti Climatici organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP.
Si terrà il 26 marzo a Roma, presso il Ministero della Salute a via Ribotta, il Convegno Nazionale, accreditato ECM, Veterinaria, Ambiente e Cambiamenti Climatici organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP. Le quattro principali organizzazioni internazionali di riferimento per la salute globale — l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (WOAH) – hanno ufficializzato il rinnovo del
Le quattro principali organizzazioni internazionali di riferimento per la salute globale — l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (WOAH) – hanno ufficializzato il rinnovo del  Negli ultimi anni i formaggi a latte crudo sono tornati protagonisti sulle tavole e nel dibattito sulla sicurezza alimentare. Questa vasta gamma di prodotti artigianali, spesso tipici di specifici contesti rurali, sono apprezzati per i loro supposti valori di “naturalità” e tradizione. Tuttavia, il loro consumo può esporre i consumatori a pericoli sanitari, legati alla possibile contaminazione con Escherichia coli produttori di shigatossine (STEC), responsabili di gravi forme di tossinfezione alimentare nell’uomo.
Negli ultimi anni i formaggi a latte crudo sono tornati protagonisti sulle tavole e nel dibattito sulla sicurezza alimentare. Questa vasta gamma di prodotti artigianali, spesso tipici di specifici contesti rurali, sono apprezzati per i loro supposti valori di “naturalità” e tradizione. Tuttavia, il loro consumo può esporre i consumatori a pericoli sanitari, legati alla possibile contaminazione con Escherichia coli produttori di shigatossine (STEC), responsabili di gravi forme di tossinfezione alimentare nell’uomo. Il Presidente Onorario SIMeVeP, Aldo Grasselli, sta partecipando all’evento formativo “Strategie di rete One Health nella cooperazione internazionale” realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta in collaborazione con SIMeVeP.
Il Presidente Onorario SIMeVeP, Aldo Grasselli, sta partecipando all’evento formativo “Strategie di rete One Health nella cooperazione internazionale” realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta in collaborazione con SIMeVeP.


 Aldo Grasselli, Segretario Nazionale SIVeMP, Antonio Sorice, Presidente SIMeVeP, Maurizio Ferri, Delegato italiano in UEVH, sezione di FVE sono intervenuti ieri a “
Aldo Grasselli, Segretario Nazionale SIVeMP, Antonio Sorice, Presidente SIMeVeP, Maurizio Ferri, Delegato italiano in UEVH, sezione di FVE sono intervenuti ieri a “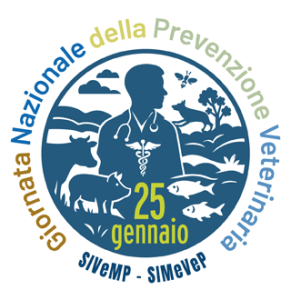 In occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria SIMeVeP e SIVeMP, in collaborazione con FVM e FESPA, hanno organizzato delle iniziative in tutta Italia per raccontare le attività di prevenzione, tutela e controllo dei Medici Veterinari del SSN.
In occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria SIMeVeP e SIVeMP, in collaborazione con FVM e FESPA, hanno organizzato delle iniziative in tutta Italia per raccontare le attività di prevenzione, tutela e controllo dei Medici Veterinari del SSN.


























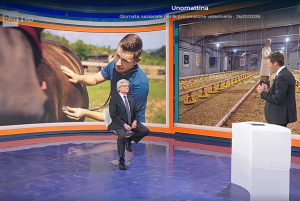 Aldo Grasselli è intervenuto ieri in diretta alla trasmissione Unomattina in onda su Rai1 con la conduzione di Massimiliano Ossini per parlare di veterinaria preventiva e del ruolo dei Medici veterinari nella salute pubblica, in occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria
Aldo Grasselli è intervenuto ieri in diretta alla trasmissione Unomattina in onda su Rai1 con la conduzione di Massimiliano Ossini per parlare di veterinaria preventiva e del ruolo dei Medici veterinari nella salute pubblica, in occasione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria