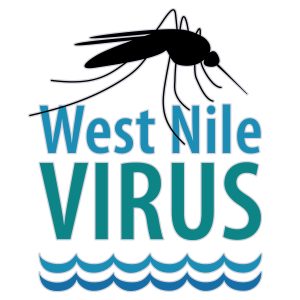
Il West Nile virus (WNV) rappresenta una crescente preoccupazione in Italia e in Europa. Questa infezione virale, trasmessa principalmente dalle zanzare del genere Culex, ha come serbatoi naturali gli uccelli, mentre cavalli e esseri umani sono ospiti a fondo cieco. In Italia, è endemica, in particolare nelle regioni che circondano il delta del Po, come Emilia-Romagna e Veneto ed i recentissimi 8 casi di infezione conclamata in Campania che hanno dato luogo ad altrettante ospedalizzazioni a causa di forme neuroinvasive, si tratta di persone che, nella maggior parte dei casi hanno villeggiato a Baia Domitia. Si ritiene che questo cluster epidemico conti già alcune centinaia di casi asintomatici, considerando che solo l’1-2 % delle infezioni provocano il ricovero ospedaliero.
Oltre alla trasmissione vettoriale, sebbene rari, sono documentati altri mezzi di contagio, tra cui trasfusioni di sangue, trapianti di organi e trasmissione verticale durante la gravidanza. È importante sottolineare che il virus non si trasmette da persona a persona per contatto diretto.
“Il problema è che i sintomi sono spesso lievi o assenti,” ricorda Antonio Sorice, Presidente SIMeVeP “per questo è difficile stimare la reale diffusione del virus”.
West Nile Virus: Sintomi e Complicanza
Dopo un periodo di incubazione che varia da 2 a 14 giorni (fino a un massimo di 21), nella maggior parte dei casi (80%) l’infezione da West Nile virus decorre senza sintomi. Il restante 20% può manifestare sintomi lievi simil-influenzali: febbre, cefalea, nausea, vomito, linfonodi ingrossati ed eruzioni cutanee.
Le forme gravi, con interessamento del sistema nervoso centrale (encefalite, meningite), sono rare ma potenzialmente letali. “Solo lo 0,5-1% dei pazienti sviluppa sintomi neurologici importanti come tremori, disturbi visivi, convulsioni, paralisi o coma soprattutto in soggetti anziani o fragili, che possono portare al decesso” precisa Maurizio Ferri, Coordinatore scientifico SIMeVeP.
Perché si diffonde
Diversi fattori ambientali e sociali favoriscono la persistenza del virus: cambiamenti climatici, urbanizzazione, globalizzazione, e soprattutto le rotte migratorie degli uccelli, che ampliano l’areale del virus. Il ciclo vitale della zanzara Culex pipiens – principale vettore in Italia – dura da una a quattro settimane ed è altamente sensibile a temperature, precipitazioni e condizioni ambientali.
“Le piogge intense seguite da ondate di caldo e gli spostamenti degli uccelli migratori hanno favorito la proliferazione delle zanzare e l’amplificazione del ciclo di trasmissione” tiene a precisare Maurizio Ferri.
Sorveglianza e previsione: il ruolo cruciale dei Servizi Veterinari
Dal 2018 sono stati notificati oltre 247 casi umani autoctoni di forme neuro-invasive. In Italia il Centro Nazionale Sangue e il Ministero della Salute stanno attuando il “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025” che adotta un sistema di sorveglianza integrata animale-ambiente-uomo per monitorare e contenere efficacemente la diffusione del virus sul territorio nazionale.
In questo contesto, la sorveglianza sanitaria svolta dai servizi veterinari del Servizio Sanitario nazionale assume un’importanza fondamentale. Questi monitorano attivamente la presenza del virus negli animali, in particolare negli uccelli selvatici (serbatoi) e nei cavalli (sentinelle), attraverso campionamenti e analisi. Questa attività permette di identificare precocemente la circolazione del virus nell’ambiente e tra gli animali, fungendo da allarme precoce per la salute umana.
“In alcuni casi il West Nile virus è stato intercettato nei vettori anche 9 giorni prima che si manifestasse il primo caso umano. Ciò dimostra quanto sia preziosa una sorveglianza precoce per attivare misure di sicurezza su trapianti e trasfusioni e implementare campagne di disinfestazione sui territori.”
Sorveglianza con un approccio One Health
La sorveglianza del West Nile virus, da parte dei Servizi Veterinari delle ASL, si articola su più livelli, coinvolgendo diverse componenti per un’azione integrata ed efficace:
- Sorveglianza Entomologica: Questa attività si concentra sul monitoraggio delle popolazioni di zanzare, in particolare quelle del genere Culex, che sono i vettori primari del virus. Vengono installate trappole per catturare le zanzare in diverse aree, specialmente quelle considerate a rischio (es. zone umide, aree peri-urbane). Le zanzare catturate vengono poi analizzate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per rilevare la presenza del WNV al loro interno. L’identificazione precoce del virus nei vettori permette di mappare le aree dove il rischio di trasmissione è più elevato e di intervenire con misure di controllo mirate (es. disinfestazioni).
- Sorveglianza sugli Equidi: I cavalli sono ospiti a fondo cieco del WNV, ma possono sviluppare sintomi neurologici gravi e sono considerati “sentinelle” dell’infezione. La sorveglianza sugli equidi prevede il monitoraggio di cavalli con sintomi neurologici sospetti e l’esecuzione di test diagnostici per confermare o escludere l’infezione da WNV.
- Sorveglianza sull’Avifauna: Gli uccelli sono i serbatoi naturali del West Nile virus, il che significa che il virus circola e si moltiplica al loro interno senza causare, nella maggior parte dei casi, sintomi evidenti. La sorveglianza sull’avifauna, in particolare su specie migratrici e stanziali, è cruciale per comprendere la diffusione geografica del virus. Vengono monitorati uccelli selvatici, sia vivi che morti, e campioni biologici vengono analizzati per la ricerca del WNV.
Queste tre forme di sorveglianza, integrate tra loro, forniscono un quadro completo della circolazione del WNV nell’ambiente, permettendo di anticipare l’insorgenza di casi umani e di attivare tempestivamente le misure di prevenzione e controllo.
Il collegamento con il Centro Nazionale Sangue ed il Centro Nazionale Trapianti
La prevenzione della trasmissione da West Nile virus tramite trasfusioni di sangue e trapianti di organi è un aspetto critico della gestione della minaccia. Il Centro Nazionale Sangue (CNS) e il Centro Nazionale Trapianti (CNT), in stretta collaborazione con il Ministero della Salute e i servizi veterinari, svolgono un ruolo chiave.
Quando i servizi veterinari rilevano la circolazione del West Nile Virus in una determinata area geografica, queste informazioni vengono immediatamente condivise con il CNS e il CNT. Questa comunicazione tempestiva consente di attuare misure preventive specifiche per la sicurezza delle donazioni. Tali misure possono includere:
- Sospensione temporanea delle donazioni di sangue nelle aree a rischio o l’introduzione di test specifici (NAT – Nucleic Acid Test) per lo screening dei donatori.
- Valutazione approfondita dei donatori di organi provenienti da aree endemiche o con sospetta esposizione al virus.
Questa collaborazione tra istituzioni è essenziale per garantire che le donazioni di sangue e organi siano sicure, minimizzando il rischio di trasmissione del WNV ai riceventi.
Il ruolo della Prevenzione
Poiché non esiste un vaccino per l’uomo contro il West Nile Virus, la prevenzione diventa fondamentale e si concentra principalmente sulla protezione dalle punture di zanzara attraverso comportamenti individuali e misure ambientali come l’utilizzo di repellenti, pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, installazione di zanzariere alle finestre, svuotamento regolare dei contenitori con acqua stagnante (vasi, secchi, piscinette) e trattamenti con insetticidi mirati in aree a rischio. È importante adottare queste misure soprattutto durante le ore serali e notturne nei mesi estivi e autunnali, quando le zanzare Culex sono più attive. Nelle aree a rischio le amministrazioni locali predispongono trattamenti di disinfestazione con insetticidi mirati soprattutto dopo la conferma di casi umani o la rilevazione del virus in campioni animali o entomologici.
One Health: un’alleanza per la salute
Il virus del Nilo Occidentale rappresenta un esempio perfetto di come la salute umana, animale e ambientale siano profondamente interconnesse. L’approccio “One Health” riconosce questa interdipendenza e promuove una collaborazione multidisciplinare per affrontare le sfide sanitarie in modo integrato. In Italia e in Europa si stanno rafforzando le politiche in tal senso con iniziative che coinvolgono diversi settori e professionalità: medici, veterinari, biologi, entomologi, ecologi e molti altri esperti lavorano insieme per comprendere e gestire la complessità del problema.
“La salute degli animali e quella dell’uomo sono indissolubilmente legate”, conclude Antonio Sorice, “il West Nile virus è un chiaro esempio di come l’approccio One Health, che integra le diverse discipline, sia l’unica strada efficace per affrontare le sfide sanitarie globali. La sorveglianza veterinaria non è solo un presidio per gli animali, ma un baluardo per la salute pubblica, soprattutto quando si tratta di proteggere le donazioni di sangue e organi.”
E la prevenzione passa da una cultura scientifica multidisciplinare condivisa e integrata, dove la sorveglianza veterinaria e la collaborazione con i centri di donazione sangue e organi sono pilastri irrinunciabili.
Scarica l’articolo
Antonio Sorice – Presidente SIMeVeP
Maurizio Ferri – Coordinatore Scientifico SIMeVeP
 Il Presidente Antonio Sorice commenta il recente rapporto del Ministero della Salute che ha confermato l’eccellenza del sistema italiano di controllo sulla sicurezza alimentare, mettendo in luce un impegno fondamentale e capillare quello dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e degli Istituti zooprofilattici Sperimentali del Paese.
Il Presidente Antonio Sorice commenta il recente rapporto del Ministero della Salute che ha confermato l’eccellenza del sistema italiano di controllo sulla sicurezza alimentare, mettendo in luce un impegno fondamentale e capillare quello dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e degli Istituti zooprofilattici Sperimentali del Paese. Il
Il  Il dott. Maurizio Ferri, coordinatore scientifico della SIMeVeP, è stato intervistato dall’Ansa sul virus della febbre del Nilo.
Il dott. Maurizio Ferri, coordinatore scientifico della SIMeVeP, è stato intervistato dall’Ansa sul virus della febbre del Nilo. (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome – SFTS) è una malattia infettiva trasmessa dalle zecche, causata dal virus SFTS (SFTSV), noto anche come Dabie bandavirus, dell’ordine Bunyavirales. È stata identificata per la prima volta nelle aree rurali della Cina nel 2009 e da allora è stata segnalata in altri paesi dell’Asia orientale come la Corea del Sud, il Giappone, il Vietnam e il Myanmar.
(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome – SFTS) è una malattia infettiva trasmessa dalle zecche, causata dal virus SFTS (SFTSV), noto anche come Dabie bandavirus, dell’ordine Bunyavirales. È stata identificata per la prima volta nelle aree rurali della Cina nel 2009 e da allora è stata segnalata in altri paesi dell’Asia orientale come la Corea del Sud, il Giappone, il Vietnam e il Myanmar.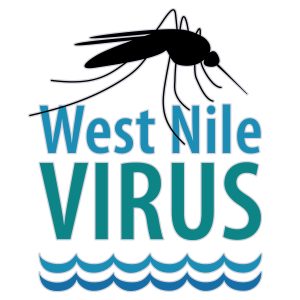

 Da oggi è possibile scaricare le presentazioni del Convegno “One Health: sfide e opportunità per un futuro sostenibile” che si è svolto ad Otranto dal 1 al 4 luglio 2025.
Da oggi è possibile scaricare le presentazioni del Convegno “One Health: sfide e opportunità per un futuro sostenibile” che si è svolto ad Otranto dal 1 al 4 luglio 2025. E’ possibile iscriversi già da oggi al corso FAD gratuito Malattie trasmesse da vettori: Focus su Febbre emorragica Crimea-Congo ed Encefalite da zecca realizzato da ACCMED in collaborazione con SIVeMP e il patrocinio di SIMeVeP, che sarà disponibile dal 4 agosto 2025 al 31 dicembre 2025.
E’ possibile iscriversi già da oggi al corso FAD gratuito Malattie trasmesse da vettori: Focus su Febbre emorragica Crimea-Congo ed Encefalite da zecca realizzato da ACCMED in collaborazione con SIVeMP e il patrocinio di SIMeVeP, che sarà disponibile dal 4 agosto 2025 al 31 dicembre 2025. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 3 luglio 2025, ha approvato la delibera per il recupero del debito formativo 2020/2022 e in materia di crediti compensativi relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 3 luglio 2025, ha approvato la delibera per il recupero del debito formativo 2020/2022 e in materia di crediti compensativi relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022. Il prestigioso Festival dei Due Mondi di Spoleto ha ospitato un evento di grande rilevanza sociale e scientifica: il convegno “Cibo che Unisce: Recupero e Ridistribuzione Alimentare per la Solidarietà verso una Comunità Antispreco”. La forte presenza della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva (SIMeVeP), su iniziativa del suo Presidente, Antonio Sorice, ha ribadito l’impegno concreto dell’associazione nella lotta allo spreco alimentare e nella promozione di pratiche virtuose per la sostenibilità e la solidarietà.
Il prestigioso Festival dei Due Mondi di Spoleto ha ospitato un evento di grande rilevanza sociale e scientifica: il convegno “Cibo che Unisce: Recupero e Ridistribuzione Alimentare per la Solidarietà verso una Comunità Antispreco”. La forte presenza della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva (SIMeVeP), su iniziativa del suo Presidente, Antonio Sorice, ha ribadito l’impegno concreto dell’associazione nella lotta allo spreco alimentare e nella promozione di pratiche virtuose per la sostenibilità e la solidarietà.
 Tavola Rotonda: Condivisione di Esperienze per una Maggiore Solidarietà
Tavola Rotonda: Condivisione di Esperienze per una Maggiore Solidarietà