Peste suina africana (PSA): le indicazioni di ISPRA
Il Ministero della Salute con il supporto dell’Unità di Crisi Centrale e il Gruppo di Esperti in materia di PSA, ai quali ISPRA partecipa, sta attivando con urgenza le procedure sia per la delimitazione dell’area infetta sia per contrastare l’ulteriore diffusione della malattia.
La PSA è una malattia infettiva altamente contagiosa in grado di provocare un’elevata mortalità nei suidi sia domestici sia selvatici di qualsiasi età e sesso. Il virus rimane vitale per lungo tempo anche dopo la morte dell’animale, rendendo le carcasse ancora infettanti e in grado di trasmettere il virus. Per tale motivo è di cruciale importanza la segnalazione immediata del ritrovamento di cinghiali morti, anche se incompleti o in avanzato stato di decomposizione, ai Servizi Veterinari localmente competenti (anche per tramite di Carabinieri forestali, Polizia provinciale, Polizia locale).
Perché si tratta di attività che comportano un duplice rischio: la movimentazione di cinghiali potenzialmente infetti sul territorio, soprattutto conseguente al ricorso di tecniche che utilizzano i cani, e la diffusione involontaria del virus attraverso calzature, indumenti, attrezzature e veicoli.
Perché è importante regolamentare qualsiasi tipo di attività venatoria nell’area confinante con la zona infetta (entro 10 km dal confine)?
Perché, considerati i rischi che comporta per la diffusione della Peste suina africana, è importante che siano adottate modalità di prelievo venatorio, volte a limitare al massimo il disturbo ai cinghiali per non aumentarne la mobilità, unitamente a misure di biosicurezza in grado di ridurre il rischio di diffusione del virus come effetto della contaminazione di indumenti, scarpe, materiali e veicoli.
La comparsa della Peste suina africana è dovuta alle elevate densità di cinghiale?
No, la comparsa del virus è totalmente indipendente dalle densità di cinghiale. Le popolazioni di cinghiale infette più vicine all’Italia vivono a diverse centinaia di km di distanza. La comparsa dell’infezione nel cinghiale in Piemonte e Liguria è sicuramente dovuta all’inconsapevole introduzione del virus da parte dell’uomo.
L’elevata densità del cinghiale favorisce la persistenza del virus?
La densità del cinghiale non ha effetti significativi sulla persistenza in natura della Peste suina africana. La notevole resistenza del virus nell’ambiente fa sì che la malattia continui a circolare per anni, anche in popolazioni di cinghiale a densità bassissime (es. circa 0,5/km2).
Allungare il periodo consentito per la caccia in braccata in questa fase epidemiologica è utile a prevenire la diffusione delle Peste suina africana?
No. In questa fase in cui è ancora in corso di definizione l’area effettivamente interessata dall’infezione, è anzi fortemente consigliato evitare qualsiasi attività che possa causare la dispersione degli animali sul territorio e con essa la possibile diffusione del virus, sia in modo diretto, aumentando la mobilità di eventuali cinghiali infetti, sia in modo indiretto, come effetto della contaminazione di indumenti, scarpe, materiali e veicoli.
Secondo le simulazioni effettuate, per poter rallentare significativamente la diffusione della Peste suina africana si dovrebbe rimuovere nel brevissimo periodo la quasi totalità della popolazione di cinghiale (circa il 90%), obiettivo irrealistico da raggiungere nella gran parte dei contesti presenti sul territorio nazionale.
La presenza del lupo contribuisce alla diffusione della Peste suina africana?
La presenza del lupo non appare avere effetti rilevanti sulla diffusione della Peste suina africana. Recenti studi effettuati in aree infette della Polonia, hanno verificato l’assenza totale del virus nelle feci di lupo, dimostrando che il passaggio nel tratto intestinale ne provoca la degradazione completa. Inoltre gli enzimi presenti nella saliva danneggiano la superficie esterna del virus limitandone l’infettività. Al contrario, il lupo potrebbe contribuire a limitare la circolazione della Peste suina africana sia predando di preferenza gli individui malati, sia consumando le carcasse infette.
Cosa fare se si trova una carcassa di cinghiale in un’area al di fuori della zona infetta?
Segnalarla immediatamente ai Servizi veterinari regionali, mediante il numero appositamente creato da ciascuna regione o eventualmente utilizzando il 112, fornendo indicazioni sull’ubicazione precisa e opportuna documentazione fotografica del ritrovamento.
***
ISPRA sottolinea la necessità di seguire rigorosamente le indicazioni tecniche della autorità nazionali competenti (con le quali ISPRA collabora costantemente) e l’importanza cruciale della ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, da segnalare immediatamente ai Servizi veterinari regionali in caso di ritrovamento.
Le indicazioni della autorità nazionali competenti sono articolate nei tre livelli territoriali individuati: zona infetta; area confinante con la zona infetta (entro 10 km dal confine); intero territorio nazionale.
Nella zona infetta è prioritario assicurare una gestione della popolazione di cinghiale coordinata e efficace, con l’unico scopo di ottenere nel breve periodo l’eradicazione del virus, condizione essenziale per riprendere le normali attività di allevamento, caccia, trekking, mountain biking, utilizzo del bosco e fruizione pubblica delle aree naturali in essere precedentemente all’epidemia.
Al di fuori della zona infetta e dell’area confinante, al momento l’unica prescrizione delle autorità nazionali competenti riguarda la movimentazione dei cinghiali vivi; resta ferma per le autorità locali competenti la possibilità di introdurre ulteriori misure restrittive.
Misure inerenti all’ambito faunistico
Fonte: ISPRA
 Il 7 gennaio scorso è stata confermata dal Centro di Referenza Nazionale per le Pesti suine dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” la presenza della peste suina africana (PSA) al confine tra Piemonte e Liguria.
Il 7 gennaio scorso è stata confermata dal Centro di Referenza Nazionale per le Pesti suine dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” la presenza della peste suina africana (PSA) al confine tra Piemonte e Liguria.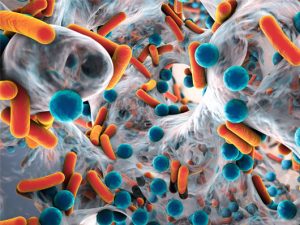 I cloni di Escherichia coli che infettano o colonizzano l’uomo e gli animali allevati per la produzione di alimenti potrebbero circolare fra le diverse specie che li ospitano, scambiandosi geni che conferiscono meccanismi di resistenza agli antibiotici. Per questo è importante adottare un approccio One Health nella sorveglianza dell’
I cloni di Escherichia coli che infettano o colonizzano l’uomo e gli animali allevati per la produzione di alimenti potrebbero circolare fra le diverse specie che li ospitano, scambiandosi geni che conferiscono meccanismi di resistenza agli antibiotici. Per questo è importante adottare un approccio One Health nella sorveglianza dell’ one del Convegno Internazionale di Elicicoltura, promosso dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco è stato il momento centrale di Helix 2021. Hanno partecipato al convegno i massimi esponenti della Sanità Veterinaria italiana e internazionale. Sono intervenuti infatti il Consigliere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, Romano Marabelli, il Direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, Pierdavide Lecchini, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, e Giorgio Maria Bergesio, Componente della IX Commissione Permanente
one del Convegno Internazionale di Elicicoltura, promosso dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco è stato il momento centrale di Helix 2021. Hanno partecipato al convegno i massimi esponenti della Sanità Veterinaria italiana e internazionale. Sono intervenuti infatti il Consigliere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, Romano Marabelli, il Direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, Pierdavide Lecchini, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, e Giorgio Maria Bergesio, Componente della IX Commissione Permanente  Baylisascaris procyonis è un nematode endemico del Nordamerica e sporadicamente segnalato in altri Paesi: in Italia è stato segnalato per la prima volta nel 2021 da 5 procioni abbattuti nel territorio del Casentino (AR).
Baylisascaris procyonis è un nematode endemico del Nordamerica e sporadicamente segnalato in altri Paesi: in Italia è stato segnalato per la prima volta nel 2021 da 5 procioni abbattuti nel territorio del Casentino (AR). Uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha riportato la presenza di alcune specie di flebotomi in aree della Pianura Padana dove non erano mai stati segnalati prima, e che possono trasmettere la
Uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha riportato la presenza di alcune specie di flebotomi in aree della Pianura Padana dove non erano mai stati segnalati prima, e che possono trasmettere la  L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), collaborano da tempo per essere pronti nel prevenire, prevedere, rilevare e rispondere alle minacce per la salute globale e promuovere uno sviluppo sostenibile.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), collaborano da tempo per essere pronti nel prevenire, prevedere, rilevare e rispondere alle minacce per la salute globale e promuovere uno sviluppo sostenibile.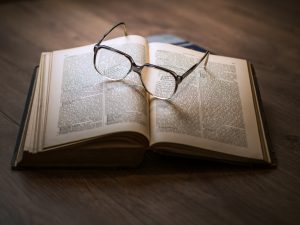 Nuova uscita per “Appunti di scienza”, la collana di
Nuova uscita per “Appunti di scienza”, la collana di  iorno 23 aprile sono stati trovati due adulti di Vespa velutina in una bottiglia trappola posizionata presso un apiario a San Damiano al Colle, un comune della provincia di Pavia sulle colline dell’Oltrepò Pavese, ai confini con la provincia di Piacenza.
iorno 23 aprile sono stati trovati due adulti di Vespa velutina in una bottiglia trappola posizionata presso un apiario a San Damiano al Colle, un comune della provincia di Pavia sulle colline dell’Oltrepò Pavese, ai confini con la provincia di Piacenza. Un nuovo importante
Un nuovo importante  In Giappone è stato scoperto un nuovo virus che può essere trasmesso da punture di zecca. Soprannominato virus Yezo (YEZV), può causare febbre e altri sintomi negli esseri umani. Un caso della misteriosa malattia è stato registrato nel 2019 dopo che un uomo di 41 anni è stato ricoverato in ospedale con sintomi, tra cui febbre e dolore alle gambe, ha
In Giappone è stato scoperto un nuovo virus che può essere trasmesso da punture di zecca. Soprannominato virus Yezo (YEZV), può causare febbre e altri sintomi negli esseri umani. Un caso della misteriosa malattia è stato registrato nel 2019 dopo che un uomo di 41 anni è stato ricoverato in ospedale con sintomi, tra cui febbre e dolore alle gambe, ha