 Ricercatori dell’IZSVe hanno identificato due genotipi di virus influenzali finora sconosciuti in Italia, denominati Novel 1 e Novel 2, in popolazioni di suini. La scoperta è avvenuta nell’ambito di uno studio di sorveglianza in allevamenti suini del Nord-Est, pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology. Il genotipo Novel 1, appartenente al sottotipo H1avN2, è stato isolato in Friuli Venezia Giulia, mentre il genotipo Novel 2, riconducibile al sottotipo H1pdmN2, è stato identificato in Veneto. Lo studio prosegue una linea di ricerca che già nel 2018 aveva permesso di identificare altri genotipi virali.
Ricercatori dell’IZSVe hanno identificato due genotipi di virus influenzali finora sconosciuti in Italia, denominati Novel 1 e Novel 2, in popolazioni di suini. La scoperta è avvenuta nell’ambito di uno studio di sorveglianza in allevamenti suini del Nord-Est, pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology. Il genotipo Novel 1, appartenente al sottotipo H1avN2, è stato isolato in Friuli Venezia Giulia, mentre il genotipo Novel 2, riconducibile al sottotipo H1pdmN2, è stato identificato in Veneto. Lo studio prosegue una linea di ricerca che già nel 2018 aveva permesso di identificare altri genotipi virali.
L’influenza suina è una malattia respiratoria dei suini diffusa in tutto il mondo, con importanti implicazioni per la salute animale e umana.
“Il suino è una specie estremamente interessante per lo studio dei ceppi influenzali, dal momento che è suscettibile all’infezione di ceppi influenzali di diversa origine, suina, umana e aviare” spiega Lara Cavicchio, biotecnologa ricercatrice del Laboratorio di genomica e trascrittomica virale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), prima autrice dell’articolo. “Per questa ragione il suino rappresenta un mixing vessel, una sorta di ‘miscelatore’ dove i virus influenzali di diversa origine possono andare incontro ad eventi di riassortimento, cioè si scambiano pezzi di materiale genetico, creando nuove varianti, potenzialmente pericolose per l’uomo.”
Un esempio tangibile delle conseguenze negative di questo meccanismo si è avuto con la prima pandemia del XXI secolo. Era il 2009 e a scatenarla fu un virus influenzale H1N1 originato dal riassortimento fra ceppi virali suini, umani e aviari. La sorveglianza è dunque fondamentale per monitorare la circolazione e l’evoluzione di questi virus, al fine di studiare il loro potenziale zoonosico ed eventualmente pandemico.
L’analisi genetica evidenzia la circolazione inter aziendale del virus
Grazie alla collaborazione tra veterinari aziendali e ricercatori, sono stati raccolti tra il 2013 e il 2022 oltre 3.000 campioni in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige da animali sintomatici: circa il 19% è risultato positivo a influenza suina. La maggior parte dei campioni positivi proviene dalle aree a più alta densità suinicola, nelle province di Padova, Verona, Treviso, Pordenone e Udine.
Con la caratterizzazione genetica dei due nuovi genotipi “italiani” Novel 1 e Novel 2, ad oggi i genotipi noti nel Nord est sono dodici, di cui dieci già descritti precedentemente (A, B, D, F, M, P, T, U, AH e Novel2013).
L’analisi filogenetica, effettuata per tracciare la storia evolutiva dei virus e le loro “parentele”, ha evidenziato la presenza di distinti cluster genetici, costituiti da virus strettamente correlati in allevamenti diversi, e ha rilevato una positività ricorrente a virus influenzali suini in numerose aziende nel corso del periodo di sorveglianza. Questi dati suggeriscono sia la persistenza intra-aziendale di specifici ceppi, sia reintroduzioni ricorrenti legate alle dinamiche di filiera.
La presenza di cluster genetici condivisi tra allevamenti, spesso localizzati in aree geografiche contigue o appartenenti alla stessa rete produttiva, indica fenomeni di diffusione inter-aziendale. In alcuni casi, le sequenze virali mostravano elevata similarità con ceppi umani, coerente con possibili eventi di trasmissione interspecifica.
Leggi l’articolo
Fonte: IZS Venezie
 Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), QU Dongyu, ha esortato venerdì i Paesi membri a rafforzare le partnership globali per prevenire e controllare le malattie animali transfrontaliere (TAD), avvertendo che rappresentano una delle minacce più urgenti alla sicurezza alimentare globale e alla stabilità economica.
Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), QU Dongyu, ha esortato venerdì i Paesi membri a rafforzare le partnership globali per prevenire e controllare le malattie animali transfrontaliere (TAD), avvertendo che rappresentano una delle minacce più urgenti alla sicurezza alimentare globale e alla stabilità economica. Monitorare i salti di specie dei virus influenzali prima che diventino un’emergenza è l’obiettivo di FluWarning, un sistema digitale di allerta precoce sviluppato dal Politecnico di Milano e dall’Università degli Studi di Milano. Analizzando milioni di sequenze virali depositate su GISAID, il software riconosce variazioni genetiche anomale che possono indicare il passaggio del virus da una specie all’altra, come accaduto nell’ultimo anno con l’H5N1 nei bovini da latte negli Stati Uniti. Lo
Monitorare i salti di specie dei virus influenzali prima che diventino un’emergenza è l’obiettivo di FluWarning, un sistema digitale di allerta precoce sviluppato dal Politecnico di Milano e dall’Università degli Studi di Milano. Analizzando milioni di sequenze virali depositate su GISAID, il software riconosce variazioni genetiche anomale che possono indicare il passaggio del virus da una specie all’altra, come accaduto nell’ultimo anno con l’H5N1 nei bovini da latte negli Stati Uniti. Lo  Tra il 6 settembre e il 14 novembre 2025 sono stati segnalati 1 443 casi di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) A(H5) negli uccelli selvatici in 26 Paesi europei, quattro volte in più rispetto allo stesso periodo nel 2024 e il numero più alto quanto meno dal 2016.
Tra il 6 settembre e il 14 novembre 2025 sono stati segnalati 1 443 casi di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) A(H5) negli uccelli selvatici in 26 Paesi europei, quattro volte in più rispetto allo stesso periodo nel 2024 e il numero più alto quanto meno dal 2016.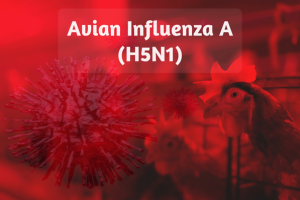 La crescente diffusione del clade 2.3.4.4b del virus dell’influenza aviaria A(H5N1) a numerose specie di volatili e di mammiferi domestici e selvatici desta fondati motivi di allarme. Preoccupa particolarmente, in un siffatto contesto, la documentata acquisizione dell’infezione da parte di specie la cui conservazione in natura appare già seriamente minacciata, quali l’orso polare in Alaska, i leoni e gli elefanti marini sudamericani, nonché delfini e focene lungo le coste nordamericane e scandinave (Di Guardo, 2025). Ulteriore preoccupazione la giustificano, altresì, i reiterati casi di malattia umana in allevatori statunitensi, conseguenti ad esposizione/consumo di latte non pastorizzato proveniente dai numerosi allevamenti bovini colpiti dal virus in USA (Garg et al., 2025).. In un caso di malattia recentemente diagnosticato in un paziente cileno, l’agente responsabile possedeva inoltre il medesimo profilo genetico del virus isolato da leoni marini deceduti lungo le coste di quel Paese (Pardo-Roa et al., 2025). Fortunatamente, il virus dell’influenza aviaria A(H5N1) non avrebbe ancora acquisito, nonostante i continui eventi mutazionali a carico del proprio genoma, la capacità di trasmettersi efficacemente da uomo a uomo (Di Guardo, 2025).
La crescente diffusione del clade 2.3.4.4b del virus dell’influenza aviaria A(H5N1) a numerose specie di volatili e di mammiferi domestici e selvatici desta fondati motivi di allarme. Preoccupa particolarmente, in un siffatto contesto, la documentata acquisizione dell’infezione da parte di specie la cui conservazione in natura appare già seriamente minacciata, quali l’orso polare in Alaska, i leoni e gli elefanti marini sudamericani, nonché delfini e focene lungo le coste nordamericane e scandinave (Di Guardo, 2025). Ulteriore preoccupazione la giustificano, altresì, i reiterati casi di malattia umana in allevatori statunitensi, conseguenti ad esposizione/consumo di latte non pastorizzato proveniente dai numerosi allevamenti bovini colpiti dal virus in USA (Garg et al., 2025).. In un caso di malattia recentemente diagnosticato in un paziente cileno, l’agente responsabile possedeva inoltre il medesimo profilo genetico del virus isolato da leoni marini deceduti lungo le coste di quel Paese (Pardo-Roa et al., 2025). Fortunatamente, il virus dell’influenza aviaria A(H5N1) non avrebbe ancora acquisito, nonostante i continui eventi mutazionali a carico del proprio genoma, la capacità di trasmettersi efficacemente da uomo a uomo (Di Guardo, 2025).
 A seguito della epidemia di Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) in regione Sardegna e dell’avvio della campagna di vaccinazione, negli ultimi mesi il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti, documenti detenuti e le ulteriori informazioni a ciascuno degli operatori proprietari di stabilimenti di bovini nei territori interessati che ne abbia fatto richiesta.
A seguito della epidemia di Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) in regione Sardegna e dell’avvio della campagna di vaccinazione, negli ultimi mesi il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti, documenti detenuti e le ulteriori informazioni a ciascuno degli operatori proprietari di stabilimenti di bovini nei territori interessati che ne abbia fatto richiesta. Il laboratorio di biologia molecolare della sezione di Putignano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata ha recentemente sequenziato e depositato nel database NCBI la sequenza genomica (Identificativo NCBI: GCA_052601115.1) di un ceppo di Photobacterium damselae subsp. piscicida isolato presso il laboratorio di Diagnostica della sezione di Taranto dell’IZSPB.
Il laboratorio di biologia molecolare della sezione di Putignano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata ha recentemente sequenziato e depositato nel database NCBI la sequenza genomica (Identificativo NCBI: GCA_052601115.1) di un ceppo di Photobacterium damselae subsp. piscicida isolato presso il laboratorio di Diagnostica della sezione di Taranto dell’IZSPB. Ricercatori dell’IZSVe hanno identificato due genotipi di virus influenzali finora sconosciuti in Italia, denominati Novel 1 e Novel 2, in popolazioni di suini. La scoperta è avvenuta nell’ambito di uno studio di sorveglianza in allevamenti suini del Nord-Est, pubblicato sulla rivista
Ricercatori dell’IZSVe hanno identificato due genotipi di virus influenzali finora sconosciuti in Italia, denominati Novel 1 e Novel 2, in popolazioni di suini. La scoperta è avvenuta nell’ambito di uno studio di sorveglianza in allevamenti suini del Nord-Est, pubblicato sulla rivista  Nemmeno i gatti sfuggono all’influenza aviaria. I nostri animali domestici possono essere contagiati esattamente come gli essere umani e in provincia di Bologna per un micio è stato anche causa di morte. Per questo il servizio di Anatomia patologica del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna si è fatto carico di indagare il fenomeno e ha avviato un un progetto di monitoraggio dell’influenza aviaria nei gatti finanziato dalla Fondazione Carisbo denominato «Influcat-Inbo».
Nemmeno i gatti sfuggono all’influenza aviaria. I nostri animali domestici possono essere contagiati esattamente come gli essere umani e in provincia di Bologna per un micio è stato anche causa di morte. Per questo il servizio di Anatomia patologica del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna si è fatto carico di indagare il fenomeno e ha avviato un un progetto di monitoraggio dell’influenza aviaria nei gatti finanziato dalla Fondazione Carisbo denominato «Influcat-Inbo».