Studi su H5N1, mutazioni adattative nei bovini aumentano il rischio zoonotico

Due studi pubblicati su Nature Communications hanno evidenziato risultati “preoccupanti” sulla capacità del virus dell’influenza aviaria H5N1 di adattarsi ad altre specie, in particolare nei bovini, sottolineando la necessità di sorveglianza continua per evitare e prevenire eventuali salti di specie.
Dal primo caso nei bovini statunitensi nel 2024, sono stati confermati focolai in 1.084 allevamenti distribuiti in 19 stati, con 71 casi umani che hanno causato due decessi. Recentemente, inoltre, è stato identificato un caso in Europa, nei Paesi Bassi. Questi numeri testimoniano l’ampiezza della diffusione virale e la realtà del rischio zoonotico, sebbene la trasmissione interumana efficiente non sia ancora stata documentata.
Il primo studio ha esaminato il genotipo B3.13 di H5N1, che circola negli allevamenti di bovini da latte statunitensi dal 2024. I ricercatori hanno scoperto diverse mutazioni che potenziano la replicazione in cellule bovine e umane, evidenziando un processo evolutivo attivo che facilita la diffusione virale nelle mucche.
Una mutazione specifica (PB2 M631L) è stata rilevata in tutte le sequenze virali studiate, mentre un’altra (PA K497R) è apparsa in circa il 95% dei campioni analizzati. La prima è stata descritta come “la mutazione adattativa chiave” che ha permesso al genotipo B3.13 di replicarsi efficacemente nei bovini.
Ulteriori mutazioni identificate (PB2 E627K e PB2 D740N) indicano un adattamento continuo per ottimizzare la funzione della polimerasi virale nei bovini. Aspetto particolarmente rilevante, queste mutazioni sembrano avere impatto scarso o nullo sulla replicazione negli uccelli, suggerendo che potrebbero essere mantenute anche dopo possibile ritorno nel reservoire avicolo.
Fonte: vet33
 L’integrazione di sorveglianza genomica avanzata, analisi dei dati in tempo reale e strumenti di intelligenza artificiale può contribuire a individuare segnali precoci di potenziali focolai di virus Nipah e a rafforzare la preparazione pandemica. È quanto emerge da una
L’integrazione di sorveglianza genomica avanzata, analisi dei dati in tempo reale e strumenti di intelligenza artificiale può contribuire a individuare segnali precoci di potenziali focolai di virus Nipah e a rafforzare la preparazione pandemica. È quanto emerge da una Negli ultimi giorni, in diverse Regioni italiane sono stati segnalati nuovi episodi di Influenza Equina (IE), confermati dal punto di vista diagnostico. Si tratta di una malattia respiratoria virale altamente contagiosa che colpisce principalmente i cavalli e può interessare anche gli asini. Nella maggior parte dei casi l’infezione decorre senza sintomi evidenti; tuttavia, in alcune circostanze possono verificarsi episodi clinici che coinvolgono un numero elevato di animali, soprattutto in presenza di focolai epidemici.
Negli ultimi giorni, in diverse Regioni italiane sono stati segnalati nuovi episodi di Influenza Equina (IE), confermati dal punto di vista diagnostico. Si tratta di una malattia respiratoria virale altamente contagiosa che colpisce principalmente i cavalli e può interessare anche gli asini. Nella maggior parte dei casi l’infezione decorre senza sintomi evidenti; tuttavia, in alcune circostanze possono verificarsi episodi clinici che coinvolgono un numero elevato di animali, soprattutto in presenza di focolai epidemici. Come richiesto dalla Commissione europea, l’EFSA si è focalizzata sul rischio di infezione dei bovini da latte e del pollame europei da parte del virus con specifico genotipo H5N1. diffuso nei bovini da latte statunitensi. Ha descritto quindi le possibili misure di attenuazione per prevenire il suo ingresso e diffusione in Europa: ad esempio alcune restrizioni al commercio con le regioni interessate e un’accurata pulizia degli impianti di mungitura. In caso di focolaio infettivo, onde ridurne l’impatto complessivo, si consiglia un’azione congiunta in pollame e vacche da latte.
Come richiesto dalla Commissione europea, l’EFSA si è focalizzata sul rischio di infezione dei bovini da latte e del pollame europei da parte del virus con specifico genotipo H5N1. diffuso nei bovini da latte statunitensi. Ha descritto quindi le possibili misure di attenuazione per prevenire il suo ingresso e diffusione in Europa: ad esempio alcune restrizioni al commercio con le regioni interessate e un’accurata pulizia degli impianti di mungitura. In caso di focolaio infettivo, onde ridurne l’impatto complessivo, si consiglia un’azione congiunta in pollame e vacche da latte. Gli acari del genere Tropilaelaps sono originari di alcune regioni dell’Asia, dove parassitano Apis dorsata e A. breviligula. Particolarmente rilevanti per l’apicoltura europea sono le specie T. clareae e T. mercedesae, entrambe in grado di infestare A. mellifera. Questi parassiti colpiscono principalmente la covata, provocando
Gli acari del genere Tropilaelaps sono originari di alcune regioni dell’Asia, dove parassitano Apis dorsata e A. breviligula. Particolarmente rilevanti per l’apicoltura europea sono le specie T. clareae e T. mercedesae, entrambe in grado di infestare A. mellifera. Questi parassiti colpiscono principalmente la covata, provocando  Per la prima volta un virus finora noto solo per infettare insetti è stato identificato nei tessuti di due cavalli deceduti a causa di una grave sindrome respiratoria. Si tratta dell’Alphamesonivirus-1, appartenente alla famiglia dei Mesoniviridae, fino a oggi considerata esclusiva di zanzare e altri artropodi. La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Virology, è il frutto di uno studio congiunto condotto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” in collaborazione con enti di ricerca internazionali. Una ricerca che apre nuove ipotesi sulla capacità di questi virus di superare la barriera di specie.
Per la prima volta un virus finora noto solo per infettare insetti è stato identificato nei tessuti di due cavalli deceduti a causa di una grave sindrome respiratoria. Si tratta dell’Alphamesonivirus-1, appartenente alla famiglia dei Mesoniviridae, fino a oggi considerata esclusiva di zanzare e altri artropodi. La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Virology, è il frutto di uno studio congiunto condotto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” in collaborazione con enti di ricerca internazionali. Una ricerca che apre nuove ipotesi sulla capacità di questi virus di superare la barriera di specie. Il 9 dicembre 2025 l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) hanno pubblicato “The European Union One Health 2024 Zoonoses Report” (EUOHZ) [1], il report annuale sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici e sui focolai epidemici di malattie a trasmissione alimentare. Il report è basato sui dati raccolti nel 2024 da 27 Stati membri dell’Unione Europea (UE), dall’Irlanda del Nord (limitatamente ai dati su alimenti e animali e focolai epidemici di malattia trasmesse da alimenti) e da altri 8 Paesi europei non membri della UE.
Il 9 dicembre 2025 l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) hanno pubblicato “The European Union One Health 2024 Zoonoses Report” (EUOHZ) [1], il report annuale sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici e sui focolai epidemici di malattie a trasmissione alimentare. Il report è basato sui dati raccolti nel 2024 da 27 Stati membri dell’Unione Europea (UE), dall’Irlanda del Nord (limitatamente ai dati su alimenti e animali e focolai epidemici di malattia trasmesse da alimenti) e da altri 8 Paesi europei non membri della UE. Il monitoraggio e la corretta identificazione degli artropodi (insetti e acari) di interesse medico sono attività fondamentali per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dalle specie aventi attività vettoriale.
Il monitoraggio e la corretta identificazione degli artropodi (insetti e acari) di interesse medico sono attività fondamentali per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dalle specie aventi attività vettoriale.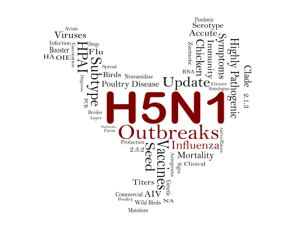 Tra il 6 settembre e il 28 novembre 2025, sono stati segnalati 442 focolai di HPAI tra gli uccelli domestici e 2 454 tra gli uccelli selvatici in 29 paesi europei, secondo
Tra il 6 settembre e il 28 novembre 2025, sono stati segnalati 442 focolai di HPAI tra gli uccelli domestici e 2 454 tra gli uccelli selvatici in 29 paesi europei, secondo  Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha pubblicato una nuova guida operativa per supportare i Paesi dell’Unione europea nella prevenzione e gestione delle minacce influenzali di origine animale con potenziale trasmissione all’uomo, alla luce dell’aumento dei casi di influenza aviaria A(H5N1) registrato nell’autunno 2025 tra uccelli selvatici e pollame in diversi Stati membri.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha pubblicato una nuova guida operativa per supportare i Paesi dell’Unione europea nella prevenzione e gestione delle minacce influenzali di origine animale con potenziale trasmissione all’uomo, alla luce dell’aumento dei casi di influenza aviaria A(H5N1) registrato nell’autunno 2025 tra uccelli selvatici e pollame in diversi Stati membri.