 Ricercatori del Centro di referenza nazione per le salmonellosi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) hanno messo a punto un nuovo protocollo basato sul sequenziamento dell’intero genoma batterico (Whole Genome Sequencing, WGS), per l’identificazione in silico – ovvero attraverso una simulazione informatica – dei più frequenti sierotipi di Salmonella circolanti in Italia. Il metodo è stato ottimizzato per identificare il pannello più ampio possibile di sierotipi.
Ricercatori del Centro di referenza nazione per le salmonellosi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) hanno messo a punto un nuovo protocollo basato sul sequenziamento dell’intero genoma batterico (Whole Genome Sequencing, WGS), per l’identificazione in silico – ovvero attraverso una simulazione informatica – dei più frequenti sierotipi di Salmonella circolanti in Italia. Il metodo è stato ottimizzato per identificare il pannello più ampio possibile di sierotipi.
La ricerca di metodi per sierotipizzare Salmonella enterica
Salmonella enterica rappresenta una delle principali cause di gastroenteriti in molti Paesi. Nella sola Unione Europea nel 2020, sono stati riportati un totale di 87.923 casi umani di salmonellosi. La tipizzazione di Salmonella si basa sull’identificazione del sierotipo, di cui ne sono stati censiti più di 2.600, che rappresenta uno strumento essenziale per la classificazione epidemiologica degli isolati.
Il metodo universalmente accettato per l’identificazione dei sierotipi di Salmonella è storicamente lo schema di Kauffmann-White, un test fenotipico che si basa sull’identificazione di antigeni presenti sulla parete batterica, la cui combinazione è specifica per ogni sierotipo. Nonostante l’utilità della sierotipizzazione tradizionale, questo metodo presenta molte limitazioni: richiede notevole esperienza da parte degli operatori, necessita di tempi di analisi variabili dipendenti dalle caratteristiche dell’isolato, e non sempre consente di ottenere un risultato soddisfacente in termini di completezza, dal momento che i batteri esprimono gli antigeni in risposta a specifiche situazioni ambientali, che non sempre possono essere controllate in condizioni di laboratorio.
Ricercatori del Centro di referenza nazione per le salmonellosi dell’IZSVe hanno messo a punto un nuovo protocollo basato sul sequenziamento dell’intero genoma batterico (WGS), per l’identificazione in silico – ovvero attraverso una simulazione informatica – dei più frequenti sierotipi di Salmonella circolanti in Italia. Lo studio rappresenta un’evidenza a supporto della fattibilità di sostituire i metodi tradizionali di tipizzazione con metodi basati sul sequenziamento del genoma.
A causa di queste evidenti criticità la comunità scientifica è impegnata da anni nella ricerca di metodi alternativi basati su caratteristiche batteriche meno soggette all’influenza dell’ambiente esterno. L’implementazione di metodiche basate sul sequenziamento dell’intero genoma batterico risponde pienamente a questa esigenza, dal momento che la composizione del DNA è geneticamente definita e non modificabile a seguito di esposizione a condizioni ambientali differenti, consentendo ai laboratori di eseguire in prima istanza la sub-tipizzazione e, contemporaneamente, di capitalizzare il dato prodotto per ulteriori caratterizzazioni degli isolati (es. Multilocus Sequence Typing, identificazione di plasmidi e di geni di antibiotico resistenza, filogenesi).
Lo studio dell’IZSVe
Lo studio condotto dai ricercatori dell’IZSVe, finanziato dal Ministero della Salute (RC 13/17), ha evidenziato una ottima concordanza tra il metodo considerato gold standard (sierotipizzazione tradizionale) e la sierotipizzazione ottenibile in silico a partire da dati di WGS su 28 sierotipi diversi, che sono stati identificati con il 100% di accuratezza. Inoltre le caratteristiche di sensibilità e specificità, ovvero inclusività ed esclusività, del nuovo metodo sono risultate adatte ad essere applicate anche a campioni contaminati.
In una fase – come quella attuale- di transizione verso l’utilizzo sempre più diffuso di analisi molecolari e/o genotipiche per la caratterizzazione di ceppi rilevanti di Salmonella, lo studio condotto dal CRN per le salmonellosi costituisce un’evidenza a supporto della fattibilità di sostituire metodi tradizionali con metodi basati sul sequenziamento dell’intero genoma batterico, anche alla luce della possibilità di capitalizzare il dato prodotto per ottenere ulteriori caratterizzazione degli isolati in un’unica sessione sperimentale.
Inoltre l’uso di metodi di sierotipizzazione basati sul sequenziamento del genoma sembra essere una strada promettente al fine di garantire continuità e retrocompatibilità con la sierotipizzazione tradizionale, da anni pietra miliare nell’ambito della sicurezza alimentare e delle azioni di sanità pubblica volte a contenere e ridurre l’impatto della Salmonellosi.
Tuttavia, prima che il WGS possa essere utilizzato per la sierotipizzazione di Salmonella, è necessaria una rigorosa fase di validazione e una valutazione attenta dei piani di transizione metodologica, che assicurino che i dati a disposizione siano appropriati per sostituire la sierotipizzazione tradizionale senza interrompere gli attuali programmi di sorveglianza. Il presente studio costituisce un passo in tale direzione, avendo dimostrato la possibilità di mantenere la compatibilità con i dati storici di sierotipizzazione, con i sistemi di sorveglianza e le strutture di prevenzione.
Fonte: IZS delle Venezie

 Ricercatori del
Ricercatori del  Il calabrone orientale, Vespa orientalis, sembra essere sbarcato anche in Sardegna. E’ del 9 Settembre la segnalazione della presenza di tale calabrone nell’isola, pervenuta alla rete STOPVelutina per mezzo di un video registrato a Cagliari da Ignazio Trogu, in cui viene ripreso un individuo adulto di Vespa orientalis.
Il calabrone orientale, Vespa orientalis, sembra essere sbarcato anche in Sardegna. E’ del 9 Settembre la segnalazione della presenza di tale calabrone nell’isola, pervenuta alla rete STOPVelutina per mezzo di un video registrato a Cagliari da Ignazio Trogu, in cui viene ripreso un individuo adulto di Vespa orientalis.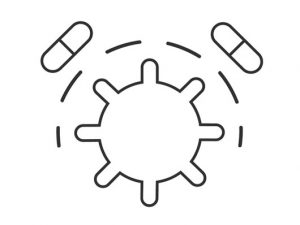 Cala l’uso di antibiotici, che ora negli animali da produzione alimentare risulta più basso che nell’uomo, si afferma nel
Cala l’uso di antibiotici, che ora negli animali da produzione alimentare risulta più basso che nell’uomo, si afferma nel  L’EFSA ha valutato il rischio di diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suini all’aperto e ha proposto misure di biosicurezza e controllo per gli allevamenti all’aperto nelle zone dell’UE colpite dalla PSA.
L’EFSA ha valutato il rischio di diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suini all’aperto e ha proposto misure di biosicurezza e controllo per gli allevamenti all’aperto nelle zone dell’UE colpite dalla PSA. 
 La trichinellosi (o trichinosi) è una malattia causata da nematodi appartenenti al genere Trichinella. Il parassita è in grado di infestare i mammiferi, gli uccelli e i rettili, soprattutto quelli carnivori e onnivori (maiale, volpe, cinghiale, cane, gatto, uomo). Il ciclo origina dal consumo di carne cruda o poco cotta di animali infestati a seguito del quale il parassita si localizza inizialmente a livello intestinale. Segue poi una fase in cui le larve migrano nei muscoli attraverso il torrente circolatorio e linfatico. A questa localizzazione muscolare nell’uomo sono associati sintomi quali edema periorbitale, dolore muscolare, febbre ed eosinofilia.
La trichinellosi (o trichinosi) è una malattia causata da nematodi appartenenti al genere Trichinella. Il parassita è in grado di infestare i mammiferi, gli uccelli e i rettili, soprattutto quelli carnivori e onnivori (maiale, volpe, cinghiale, cane, gatto, uomo). Il ciclo origina dal consumo di carne cruda o poco cotta di animali infestati a seguito del quale il parassita si localizza inizialmente a livello intestinale. Segue poi una fase in cui le larve migrano nei muscoli attraverso il torrente circolatorio e linfatico. A questa localizzazione muscolare nell’uomo sono associati sintomi quali edema periorbitale, dolore muscolare, febbre ed eosinofilia. In Italia al 18 marzo scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante inglese’ del virus Sars-CoV-2 era del 86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella ‘brasiliana’ la prevalenza era del 4,0% (0%-32,0%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, che fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane da cui era emersa una maggior trasmissibilità per la variante ‘inglese’ del 37%.
In Italia al 18 marzo scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante inglese’ del virus Sars-CoV-2 era del 86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Per quella ‘brasiliana’ la prevalenza era del 4,0% (0%-32,0%), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, che fa seguito a quelle diffuse nelle scorse settimane da cui era emersa una maggior trasmissibilità per la variante ‘inglese’ del 37%.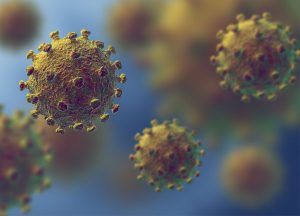 L’Istituto Superiore di Sanità, Gruppo di Lavoro Prevenzione e Controllo delle Infezioni pubblica il documento “
L’Istituto Superiore di Sanità, Gruppo di Lavoro Prevenzione e Controllo delle Infezioni pubblica il documento “