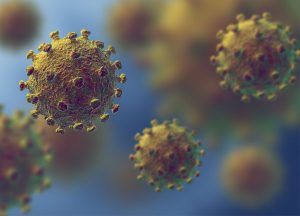 SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della COVID-19, può sopravvivere sulle superfici fino a 28 giorni, più di tutti gli altri coronavirus. La sopravvivenza del virus e la sua contagiosità sono inoltre influenzate dalle condizioni ambientali. Lo afferma una revisione sistematica della letteratura condotta dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e pubblicata su Science of the Total Environment.
SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della COVID-19, può sopravvivere sulle superfici fino a 28 giorni, più di tutti gli altri coronavirus. La sopravvivenza del virus e la sua contagiosità sono inoltre influenzate dalle condizioni ambientali. Lo afferma una revisione sistematica della letteratura condotta dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e pubblicata su Science of the Total Environment.
Il ruolo dei fomiti nella trasmissione di SARS-CoV-2
I fomiti sono oggetti inanimati o superfici porose/non porose che, se contaminati o esposti a microrganismi patogeni, possono trasferire una malattia infettiva a un nuovo ospite. Ricercatori dell’IZSVe hanno effettuato una revisione sistematica della letteratura per definire quanto i coronavirus umani (SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 e MersCoV) possono sopravvivere sulle superfici di vari fomiti.
COVID-19 è la malattia respiratoria causata da SARS-CoV-2, il virus responsabile della pandemia diffusasi in quasi 200 Paesi da fine 2019. SARS-CoV-2 si aggiunge ad altri due coronavirus umani (hCoV) noti già dal 2002 per la loro letalità e capacità di infettare l’uomo: SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus), responsabile dell’epidemia di SARS del 2002-2004, e MersCoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus), responsabile della Mers, Sindrome Respiratoria medio-orientale
Come ogni malattia emergente, anche la COVID-19 richiede l’impegno della comunità scientifica per comprenderne i meccanismi di sviluppo e di trasmissione, al fine di adeguare i protocolli diagnostici e terapeutici. Una delle tante domande a cui gli scienziati hanno cercato di trovare nel più breve tempo una risposta è stata la modalità di diffusione di SARS-CoV-2. Mentre è stato ampiamente dimostrato che la principale via di trasmissione del virus sia il contatto diretto con una persona infetta, la sua trasmissione tramite il contatto con superfici contaminate (fomiti) è ritenuta possibile ma non è ancora supportata da solide evidenze scientifiche.
I fomiti sono oggetti inanimati o superfici porose/non porose che, se contaminati o esposti a microrganismi patogeni, possono trasferire una malattia infettiva a un nuovo ospite. Sono esempi di fomiti i vestiti sporchi, gli asciugamani, le lenzuola, i fazzoletti, le medicazioni chirurgiche, gli aghi contaminati. La letteratura ha dimostrato la capacità dei fomiti di trasmettere virus respiratori e patogeni enterici, ma per SARS-CoV-2 il loro ruolo è ancora ampiamente sconosciuto. Proprio in ragione della scarsità di prove disponibili sul ruolo dei fomiti, nel rispetto del principio di precauzione numerose linee guida hanno raccomandato fin dall’inizio della pandemia come misure preventive la pulizia e disinfezione delle superfici, l’uso di guanti e l’igiene delle mani.
Un primo passo per studiare la capacità dei fomiti di traferire SARS-CoV-2 a chi vi entri in contatto è definire quanto il virus possa sopravvivere sulla superficie del fomite, raccogliendo un numero consistente di prove che dimostrino come possibile questo percorso di trasmissione del virus. Inoltre, è necessario analizzare anche la persistenza del virus nell’ambiente, che a sua volta dipende dalle caratteristiche strutturali del virus, da fattori ambientali (temperatura, umidità, esposizione ai raggi UV) e dalle caratteristiche della superficie del fomite.
Lo studio dell’IZSVe
Dallo studio è emerso che banconote (in polimero e in carta), vetro e acciaio potrebbero trasmettere il virus fino a un massimo di 21 giorni, periodo in cui la carica virale di SARS-CoV-2 è risultata essere pericolosa per l’uomo. Alte temperature combinate a un elevato tasso di umidità favoriscono l’inattivazione di SARS-CoV, così come la luce UV e quella solare.
I ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) hanno svolto una revisione sistematica della letteratura scientifica per definire quanto a lungo SARS-CoV-2 riesca a sopravvivere sulle superfici dei fomiti. La ricerca ha incluso anche gli altri due principali coronavirus umani, MersCoV e SARS-CoV vista la loro pericolosità per la salute pubblica.
La comparazione delle evidenze scientifiche pubblicate in letteratura è stata effettuata su 18 articoli scientifici, selezionati dopo lo screening di 1.436 articoli restituiti dalle banche dati come articoli pertinenti la domanda di ricerca. La sopravvivenza dei coronavirus è stata valutata su differenti materiali: polimeri (plastica, PVC, teflon, guanti monouso, …), metalli (acciaio, alluminio, rame, …), vetro, carta, legno, tessuti (stoffa, camici monouso e in cotone), mascherine, spugne sterili, ceramica, banconote, mosaici e suolo.
Dalla revisione sistematica emerge che a temperatura ambiente SARS-CoV-2 può sopravvivere fino a 28 giorni su vetro, acciaio, polimeri plastici (banconote in polimero e vinile) e banconote di carta, e fino a 7 giorni sulle mascherine chirurgiche. 28 giorni è il periodo di sopravvivenza più lungo dimostrato in laboratorio: SARS-CoV è il coronavirus che ha mostrato un tempo di sopravvivenza maggiore dopo SARS-CoV-2, sopravvivendo fino a 14 giorni su superfici di vetro. Per quanto riguarda invece la contaminazione umana tramite fomite, ovvero la capacità dei fomiti di trasmettere l’infezione, banconote (in polimero e in carta), vetro e acciaio potrebbero trasmettere il virus fino a un massimo di 21 giorni, periodo in cui la carica virale di SARS-CoV-2 è risultata essere pericolosa per l’uomo.
Anche le condizioni ambientali influenzano la capacità di sopravvivenza del virus sui fomiti: alte temperature combinate a un elevato tasso di umidità favoriscono l’inattivazione di SARS-CoV e riducono la sopravvivenza di SARS-CoV-2, mentre basse temperature e poca umidità ne aumentano le chance a prescindere dalla tipologia di superficie colonizzata dal virus. Anche la luce UV e quella solare possono ridurre la vita dei coronavirus sulle superfici: soprattutto durante la stagione estiva è molto improbabile che superfici esposte al sole (in particolare quelle in acciaio inossidabile) riescano a trasmettere il virus, suggerendo la possibile maggior contagiosità di fomiti non esposti al sole.
Verso un approccio armonizzato
Comprendere la durata dei coronavirus sulle superfici può migliorare le misure di prevenzione e renderle sempre più corrispondenti all’effettiva potenzialità del singolo fomite di fungere da fonte del virus. Questo potrebbe contribuire per esempio a ridurre l’utilizzo indiscriminato di disinfettanti e detergenti, che ha un impatto negativo sull’ambiente.
Lo studio IZSVe è un contributo alla comprensione dei coronavirus umani, in particolar modo di SARS-CoV-2 nell’ecosistema uomo-ambiente-animale: le evidenze raccolte possono essere impiegate, in particolar modo dai gestori del rischio, per migliorare le misure di prevenzione e renderle sempre più corrispondenti all’effettiva potenzialità del singolo fomite di fungere da fonte del virus. Questo potrebbe contribuire per esempio a ridurre l’utilizzo indiscriminato di disinfettanti e detergenti, che ha un impatto negativo sull’ambiente.
Nel corso di questi due anni di pandemia, la comunità scientifica ha lavorato molto allo studio della sopravvivenza di SARS-CoV-2 sulle superfici e alla loro capacità infettante: nuovi studi sperimentali o revisioni sistematiche più recenti potrebbero smentire o aggiornare le evidenze raggiunte qui presentate. Nonostante ciò, il lavoro condotto dall’IZSVe evidenzia alcuni limiti nella letteratura finora disponibile, che possono essere spunto per la ricerca futura su questo specifico tema.
Innanzitutto gli studi finora pubblicati sono difficilmente comparabili tra di loro: sussistono differenze notevoli nella metodologia impiegata nelle singole prove sperimentali, motivo per cui i ricercatori IZSVe non hanno potuto dimostrare un legame tra tempo di sopravvivenza del virus e caratteristiche della superficie contaminata, suggerendo di lavorare alla definizione di un protocollo di riferimento per la conduzione delle prove di sopravvivenza del virus.
Inoltre i risultati ottenuti dalla revisione sistematica si riferiscono a studi di laboratorio,condotti in un contesto sperimentale, motivo per cui potrebbero non restituire l’effettiva capacità di resistenza di SARS-CoV-2: sarà importante quindi condurre studi sempre più aderenti alle reali condizioni di diffusione del virus nell’ambiente.
Fonte: IZS Venezie
 E’ stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa Rivista Veterinary Record il contributo del Prof. Giovanni Di Guardo, gia’ Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo, dal titolo ‘We should be vaccinating domestic and wild animal species against Covid-19’, incentrato sull’opportunità di vaccinare nei confronti di SARS-CoV-2 le specie animali domestiche e selvatiche suscettibili all’infezione virale.
E’ stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa Rivista Veterinary Record il contributo del Prof. Giovanni Di Guardo, gia’ Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo, dal titolo ‘We should be vaccinating domestic and wild animal species against Covid-19’, incentrato sull’opportunità di vaccinare nei confronti di SARS-CoV-2 le specie animali domestiche e selvatiche suscettibili all’infezione virale.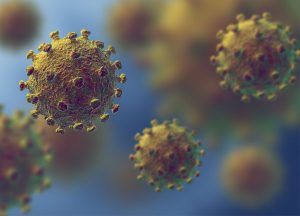 SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della COVID-19, può sopravvivere sulle superfici fino a 28 giorni, più di tutti gli altri coronavirus. La sopravvivenza del virus e la sua contagiosità sono inoltre influenzate dalle condizioni ambientali. Lo afferma una revisione sistematica della letteratura condotta dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e pubblicata su
SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della COVID-19, può sopravvivere sulle superfici fino a 28 giorni, più di tutti gli altri coronavirus. La sopravvivenza del virus e la sua contagiosità sono inoltre influenzate dalle condizioni ambientali. Lo afferma una revisione sistematica della letteratura condotta dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e pubblicata su  La lotta al doping animale: il contributo dell’intelligenza artificiale
La lotta al doping animale: il contributo dell’intelligenza artificiale Uno studio del Cnr-Irsa ha rilevato che, in acqua, i batteri che crescono sulle microparticelle derivate dagli pneumatici sono più pericolosi per l’ambiente rispetto a quelli che si sviluppano sui frammenti delle bottiglie di plastica, che invece potrebbero porre problemi per la salute dell’uomo. La ricerca è pubblicata su Journal of Hazardous Materials
Uno studio del Cnr-Irsa ha rilevato che, in acqua, i batteri che crescono sulle microparticelle derivate dagli pneumatici sono più pericolosi per l’ambiente rispetto a quelli che si sviluppano sui frammenti delle bottiglie di plastica, che invece potrebbero porre problemi per la salute dell’uomo. La ricerca è pubblicata su Journal of Hazardous Materials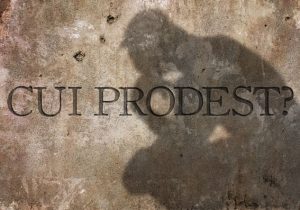 Quella del 31 Marzo 2022 rappresenta per il nostro Paese un’altra data destinata a passare alla Storia.
Quella del 31 Marzo 2022 rappresenta per il nostro Paese un’altra data destinata a passare alla Storia. Metodiche di ultima generazione per individuare rapidamente più di 70 molecole diverse: un contributo prezioso per le aziende e gli Organismi di sorveglianza
Metodiche di ultima generazione per individuare rapidamente più di 70 molecole diverse: un contributo prezioso per le aziende e gli Organismi di sorveglianza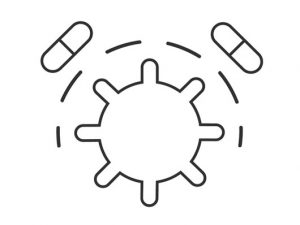 La resistenza agli antibiotici nei batteri Salmonella e Campylobacter è ancora elevata, si afferma in
La resistenza agli antibiotici nei batteri Salmonella e Campylobacter è ancora elevata, si afferma in  Creare un “Centro Sperimentale per l’Insetticoltura Sostenibile” presso la sezione di Viterbo dell’Istitututo Zooprofilattico Lazio e Toscana è la proposta presentata nei giorni scorsi dall’IZS.
Creare un “Centro Sperimentale per l’Insetticoltura Sostenibile” presso la sezione di Viterbo dell’Istitututo Zooprofilattico Lazio e Toscana è la proposta presentata nei giorni scorsi dall’IZS. La resistenza antimicrobica rappresenta una delle principali problematiche sanitarie e di salute pubblica, una minaccia per la salute e lo sviluppo globale.
La resistenza antimicrobica rappresenta una delle principali problematiche sanitarie e di salute pubblica, una minaccia per la salute e lo sviluppo globale. Negli ultimi anni l’Italia è stata colpita da eventi epidemici riconducibili a malattie trasmesse da zanzare, quali West Nile, chikungunya e dengue. Per migliorare la preparedness e le capacità di rispondere a queste minacce è importante in un paese identificare ruoli, responsabilità e attività da implementare, ottimizzando risorse umane ed economiche.
Negli ultimi anni l’Italia è stata colpita da eventi epidemici riconducibili a malattie trasmesse da zanzare, quali West Nile, chikungunya e dengue. Per migliorare la preparedness e le capacità di rispondere a queste minacce è importante in un paese identificare ruoli, responsabilità e attività da implementare, ottimizzando risorse umane ed economiche.