Il tema del clima, che aveva trovato una sua centralità nel dibattito politico internazionale per i mutamenti in atto della agenda politico istituzionale rischia di divenire derubricata dalle priorità di politica internazionale. L’attenzione al rilancio dell’energia da petrolio e derivati fa parte del pacchetto elettorale dell’attuale amministrazione USA. Il problema però continua a sussistere. I dati degli osservatori internazionali sono concordi sulle dinamiche in atto che non delineano uno scenario rassicurante. I cambiamenti climatici tendono ad avvicinarsi pericolosamente ad un livello di non ritorno. Gli impatti sull’ambiente di vita per le comunità sono rilevanti già ora … Il rapporto clima e salute è immediato. Le comunità ne risentono a secondo della loro ubicazione. È necessario aiutare una loro crescita di consapevolezza e di empowerment. Comunità proattive sono comunità più sane.
Il limite di +1,5 °C per il riscaldamento globale: perché?
È stato definito come obiettivo internazionale il 12 dicembre 2015 a Parigi. Quest obiettivo è stato sancito durante la COP21 (la ventunesima Conferenza delle Parti dell’UNFCCC), culminata nell’adozione dell’Accordo di Parigi. L’Accordo di Parigi, impegnava i Paesi firmatari a contenere l’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C, perseguendo sforzi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, basandosi sulle evidenze scientifiche dell’IPCC.
L’accordo impegnava le 195 nazioni firmatarie a mantenere l’aumento della temperatura media globale “ben al di sotto dei 2 °C” rispetto ai livelli pre-industriali, stabilendo al contempo di “proseguire gli sforzi” per limitare tale incremento all’1,5 °C. Successivamente, nel 2018, l’IPCC (Gruppo intergovernativo sui Cambiamenti Climatici) ha pubblicato un rapporto speciale che ha confermato come superare la soglia di 1,5 °C comporterebbe rischi e impatti ambientali drasticamente superiori rispetto a tale limite. Sebbene l’accordo sia entrato in vigore il 4 novembre 2016, i dati scientifici indicano che il 2024 è stato il primo anno solare a superare mediamente la soglia di 1,5 °C, rendendo l’obiettivo di Parigi sempre più critico da mantenere nel lungo periodo.
È una soglia cruciale perché superarla aumenta drasticamente il rischio di effetti climatici catastrofici e irreversibili per persone e natura, come la distruzione delle barriere coralline, la perdita di ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare, rendendo gli impatti molto più gravi rispetto all’obiettivo di 1,5°C. È un “confine planetario” scientificamente definito, non arbitrario, che separa un futuro “difficile” da uno potenzialmente “irreversibile“, attivando punti di svolta pericolosi come il collasso delle correnti oceaniche o lo scioglimento del permafrost. Ogni frazione di grado conta.
Quindi ogni scelta concreta impatta sugli equilibri dell’ecosistema terra e ne condizionano in bene o in male le condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali e vegetali, compreso l’uomo.
Leggi l’articolo
Fonte: quotidianosanità.it
 L’Oms riconosce progressi significativi nella preparazione globale, dall’Accordo Pandemico ai nuovi strumenti di sorveglianza. Ma avverte: i risultati sono fragili, i finanziamenti calano e senza cooperazione internazionale la sicurezza sanitaria resta a rischio.
L’Oms riconosce progressi significativi nella preparazione globale, dall’Accordo Pandemico ai nuovi strumenti di sorveglianza. Ma avverte: i risultati sono fragili, i finanziamenti calano e senza cooperazione internazionale la sicurezza sanitaria resta a rischio. L’etichettatura antimicrobica per un uso e uno smaltimento appropriati nella risposta globale alla resistenza antimicrobica (AMR) svolge un ruolo fondamentale.
L’etichettatura antimicrobica per un uso e uno smaltimento appropriati nella risposta globale alla resistenza antimicrobica (AMR) svolge un ruolo fondamentale. La sicurezza alimentare è emersa come una preoccupazione globale critica, laddove adulterazione, contaminazione e deterioramento coinvolgono un’ampia varietà di prodotti, dai latticini alle spezie e tanti altri. I metodi di analisi tradizionali, sebbene precisi, si rivelano spesso troppo lenti e costosi per il monitoraggio in tempo reale attraverso catene di approvvigionamento complesse. Una revisione scientifica di Balakrishnan et al. (2025) esamina come l’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) possano rivoluzionare i protocolli di sicurezza alimentare, offrendo capacità di rilevamento rapide e non invasive che trascendono gli approcci convenzionali basati su laboratorio. Questo cambio di paradigma affronta i limiti dei flussi di lavoro di test sequenziali abilitando l’elaborazione simultanea dei dati e l’analisi predittiva (Balakrishanan et al., 2025; Karanth et al., 2023).
La sicurezza alimentare è emersa come una preoccupazione globale critica, laddove adulterazione, contaminazione e deterioramento coinvolgono un’ampia varietà di prodotti, dai latticini alle spezie e tanti altri. I metodi di analisi tradizionali, sebbene precisi, si rivelano spesso troppo lenti e costosi per il monitoraggio in tempo reale attraverso catene di approvvigionamento complesse. Una revisione scientifica di Balakrishnan et al. (2025) esamina come l’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) possano rivoluzionare i protocolli di sicurezza alimentare, offrendo capacità di rilevamento rapide e non invasive che trascendono gli approcci convenzionali basati su laboratorio. Questo cambio di paradigma affronta i limiti dei flussi di lavoro di test sequenziali abilitando l’elaborazione simultanea dei dati e l’analisi predittiva (Balakrishanan et al., 2025; Karanth et al., 2023). È stato formalmente adottato il Programma triennale “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, documento strategico che rafforza l’integrazione tra politiche sanitarie e ambientali e consolida l’approccio One Health nella prevenzione dei rischi ambientali e climatici per la salute.
È stato formalmente adottato il Programma triennale “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, documento strategico che rafforza l’integrazione tra politiche sanitarie e ambientali e consolida l’approccio One Health nella prevenzione dei rischi ambientali e climatici per la salute. L’integrazione di sorveglianza genomica avanzata, analisi dei dati in tempo reale e strumenti di intelligenza artificiale può contribuire a individuare segnali precoci di potenziali focolai di virus Nipah e a rafforzare la preparazione pandemica. È quanto emerge da una
L’integrazione di sorveglianza genomica avanzata, analisi dei dati in tempo reale e strumenti di intelligenza artificiale può contribuire a individuare segnali precoci di potenziali focolai di virus Nipah e a rafforzare la preparazione pandemica. È quanto emerge da una Il modo in cui la carne viene conservata dagli operatori del settore alimentare prima di arrivare ai consumatori può influire sulla proliferazione dei batteri. Ciò vale sia per i batteri nocivi come Salmonella e Listeria sia per i batteri che rovinano solo l’odore e l’aspetto della carne.
Il modo in cui la carne viene conservata dagli operatori del settore alimentare prima di arrivare ai consumatori può influire sulla proliferazione dei batteri. Ciò vale sia per i batteri nocivi come Salmonella e Listeria sia per i batteri che rovinano solo l’odore e l’aspetto della carne. L’obiettivo del documento non è la produzione immediata di risultati. Il Piano stabilisce criteri, metodi e strumenti per l’elaborazione dei dati epidemiologici e genomici raccolti nei Paesi europei.
L’obiettivo del documento non è la produzione immediata di risultati. Il Piano stabilisce criteri, metodi e strumenti per l’elaborazione dei dati epidemiologici e genomici raccolti nei Paesi europei.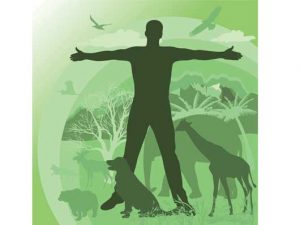 Gli impatti sull’ambiente di vita per le comunità sono rilevanti già ora … Il rapporto clima e salute è immediato. Le comunità ne risentono a secondo della loro ubicazione. È necessario aiutare una loro crescita di consapevolezza e di empowerment. Comunità proattive sono comunità più sane.
Gli impatti sull’ambiente di vita per le comunità sono rilevanti già ora … Il rapporto clima e salute è immediato. Le comunità ne risentono a secondo della loro ubicazione. È necessario aiutare una loro crescita di consapevolezza e di empowerment. Comunità proattive sono comunità più sane. Il mondo è entrato nell’era della bancarotta idrica globale: viviamo in una situazione in cui l’uso e l‘inquinamento delle fonti d’acqua hanno superato le possibilità di rinnovamento e non potranno essere più riportate ai livelli precedenti.
Il mondo è entrato nell’era della bancarotta idrica globale: viviamo in una situazione in cui l’uso e l‘inquinamento delle fonti d’acqua hanno superato le possibilità di rinnovamento e non potranno essere più riportate ai livelli precedenti. L’animale più pericoloso al mondo è sempre più assetato di sangue umano. Detta così potrebbe sembrare l’incipit di un film dell’orrore, ma in realtà c’è un motivo specifico per cui le zanzare scelgono sempre più spesso di nutrirsi del nostro sangue e, guarda caso, è una questione che ha a che fare proprio con le azioni dell’uomo. Con la perdita di biodiversità innescata dalle scelte antropiche le zanzare femmine, in luoghi dove vengono a mancare le foreste e si riducono gli habitat, tendono a causa di meno vertebrati “a disposizione” a preferire l’uomo quando devono nutrirsi. Conclusioni a cui è arrivato un
L’animale più pericoloso al mondo è sempre più assetato di sangue umano. Detta così potrebbe sembrare l’incipit di un film dell’orrore, ma in realtà c’è un motivo specifico per cui le zanzare scelgono sempre più spesso di nutrirsi del nostro sangue e, guarda caso, è una questione che ha a che fare proprio con le azioni dell’uomo. Con la perdita di biodiversità innescata dalle scelte antropiche le zanzare femmine, in luoghi dove vengono a mancare le foreste e si riducono gli habitat, tendono a causa di meno vertebrati “a disposizione” a preferire l’uomo quando devono nutrirsi. Conclusioni a cui è arrivato un