Rapporto One-Health sulle zoonosi nel 2024 nell’Unione europea
 Il 9 dicembre 2025 l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) hanno pubblicato “The European Union One Health 2024 Zoonoses Report” (EUOHZ) [1], il report annuale sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici e sui focolai epidemici di malattie a trasmissione alimentare. Il report è basato sui dati raccolti nel 2024 da 27 Stati membri dell’Unione Europea (UE), dall’Irlanda del Nord (limitatamente ai dati su alimenti e animali e focolai epidemici di malattia trasmesse da alimenti) e da altri 8 Paesi europei non membri della UE.
Il 9 dicembre 2025 l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) hanno pubblicato “The European Union One Health 2024 Zoonoses Report” (EUOHZ) [1], il report annuale sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici e sui focolai epidemici di malattie a trasmissione alimentare. Il report è basato sui dati raccolti nel 2024 da 27 Stati membri dell’Unione Europea (UE), dall’Irlanda del Nord (limitatamente ai dati su alimenti e animali e focolai epidemici di malattia trasmesse da alimenti) e da altri 8 Paesi europei non membri della UE.
Anche nel 2025, per i contenuti relativi al settore animale e alimentare nonché ai focolai epidemici di malattie a trasmissione alimentare, l’EFSA ha affidato la produzione del report EUOHZ al Consorzio ZOE (Zoonoses under a One health perspective in the EU) composto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVE), Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e Molise (IZSAM), con il coordinamento dall’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES-Francia).
I dati europei del 2024 in sintesi
- Nel 2024, la campilobatteriosi si conferma la zoonosi maggiormente riportata tra i Paesi UE con 168.396 casi, seguita dalla salmonellosi (79.703 casi), infezioni da Escherichia coli produttori di Shigatossina (STEC) (11.738 casi) e listeriosi (3.041 casi). Per tutte queste zoonosi il numero dei casi registrati nel 2024 è stato superiore allo scorso anno e il più alto negli ultimi 5 anni.
- Listeria monocytogenes continua a rappresentare l’agente associato alla maggiore gravità degli esiti di salute per i pazienti. Nel 2024, la proporzione di ospedalizzazione tra i casi di listeriosi è stata del 97,3% su 1.715 casi riportati all’ECDC con informazione sull’ospedalizzazione disponibile e del 72,3% su 210 casi epidemici di listeriosi riportati all’EFSA nell’ambito dei focolai epidemici. Il tasso di letalità è stato pari al 15,6% su 1.701 casi di listeriosi con informazione sull’esito disponibile riportati all’ECDC e dell’8,1% sui casi epidemici di listeriosi riportati all’EFSA nell’ambito dei focolai epidemici.
- Per quanto riguarda la sorveglianza dei casi di malattia nell’uomo è da sottolineare che differentemente dai precedenti report, in quello relativo al 2024 sono descritti i dati raccolti dall’ ECDC sulle sole zoonosi menzionate nell’allegato A della Direttiva zoonosi 2003/99/EC [1]. Queste comprendono oltre alle malattie riportate al punto precedente anche tubercolosi da Mycobacterium bovis e M. caprae (171 casi), brucellosi (273 casi), trichinellosi (102 casi) ed echinococcosi (984 casi).
- I dati raccolti dall’ EFSA sui focolai di malattia a trasmissione alimentare (MTA) considerano invece gli eventi epidemici associati a qualsiasi virus, batterio, alga, fungo, parassita e dai loro prodotti, tossine e ammine biologiche (per esempio: istamina) trasmessi da alimenti, non solo dagli agenti zoonotici.
- Il numero di focolai epidemici di MTA riportati in UE nel 2024 è cresciuto del 14,5% rispetto all’anno precedente (6.558 focolai nel 2024; 5.728 nel 2023) ed analogamente sono cresciuti anche il numero di casi epidemici (62.481 casi nel 2024; 10.266 casi in più nel 2024 rispetto al 2023) e delle ospedalizzazioni (3.336 ospedalizzazioni nel 2024; 440 ospedalizzazioni in più rispetto al 2023). Al contrario il numero di decessi è diminuito di 12 casi rispetto al 2023 (53 decessi nel 2024; 65 nel 2023). Tra i casi epidemici, i decessi sono stati principalmente associati a focolai da Salmonella e L. monocytogenes.
- Salmonella è stato l’agente eziologico più frequentemente associato a focolai epidemici di origine alimentare anche nel 2024 (1.238). Tra questi S. Enteritidis è stato il sierotipo maggiormente identificato (512 focolai epidemici) seguita da S. Typhimurium (84 focolai) e dalla variante monofasica di S. Typhimurium (34 focolai).
- Il report fornisce un aggiornamento anche sul monitoraggio nelle filiere alimentari e nel settore animale delle zoonosi prioritarie e di altre zoonosi in Europa, attraverso dati raccolti dai Paesi europei e trasmessi all’EFSA.
Insieme alla pubblicazione del Report EUOHZ 2024, l’EFSA ha anche aggiornato gli strumenti di comunicazione (Story map) e consultazione interattiva online dei dati (Dashboard) sul monitoraggio dei diversi patogeni nella filiera animale e alimentare. Questi strumenti permettono di interrogare attivamente i dati di monitoraggio raccolti negli ultimi 5 anni nell’UE, relativi a Campylobacter, Salmonella, Listeria monocytogenes, STEC, Tubercolosi da M. bovis/M. caprae, Trichinella, Echinococcus, West Nile e ai focolai epidemici di malattie a trasmissione alimentare.
Fonte: ISS
 Il monitoraggio e la corretta identificazione degli artropodi (insetti e acari) di interesse medico sono attività fondamentali per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dalle specie aventi attività vettoriale.
Il monitoraggio e la corretta identificazione degli artropodi (insetti e acari) di interesse medico sono attività fondamentali per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dalle specie aventi attività vettoriale. Un aumento che non ci si aspettava. Dopo oltre dieci anni di calo costante, le vendite di antimicrobici destinati agli animali da allevamento sono tornate a crescere in Europa. A certificarlo è il nuovo
Un aumento che non ci si aspettava. Dopo oltre dieci anni di calo costante, le vendite di antimicrobici destinati agli animali da allevamento sono tornate a crescere in Europa. A certificarlo è il nuovo  Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha pubblicato una nuova guida operativa per supportare i Paesi dell’Unione europea nella prevenzione e gestione delle minacce influenzali di origine animale con potenziale trasmissione all’uomo, alla luce dell’aumento dei casi di influenza aviaria A(H5N1) registrato nell’autunno 2025 tra uccelli selvatici e pollame in diversi Stati membri.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha pubblicato una nuova guida operativa per supportare i Paesi dell’Unione europea nella prevenzione e gestione delle minacce influenzali di origine animale con potenziale trasmissione all’uomo, alla luce dell’aumento dei casi di influenza aviaria A(H5N1) registrato nell’autunno 2025 tra uccelli selvatici e pollame in diversi Stati membri. Pubblicato il nuovo Piano strategico 2025-2030 per la gestione delle minacce da coronavirus, attuali e future, e da Mers (Sindrome respiratoria mediorientale), firmato dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Si tratta del primo piano unificato contro questo tipo di patologie e rappresenta un punto strategico nell’evoluzione tra la risposta emergenziale e la gestione a lungo termine integrata.
Pubblicato il nuovo Piano strategico 2025-2030 per la gestione delle minacce da coronavirus, attuali e future, e da Mers (Sindrome respiratoria mediorientale), firmato dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Si tratta del primo piano unificato contro questo tipo di patologie e rappresenta un punto strategico nell’evoluzione tra la risposta emergenziale e la gestione a lungo termine integrata.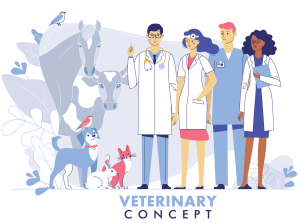 In vista della prima Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria del 25 gennaio 2026, One Health pubblica una serie di contributi firmati dai Direttori Generali dei dieci Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani. Questo articolo è a cura di Antonia Ricci, Direttrice Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).
In vista della prima Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria del 25 gennaio 2026, One Health pubblica una serie di contributi firmati dai Direttori Generali dei dieci Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani. Questo articolo è a cura di Antonia Ricci, Direttrice Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). Un uomo anziano con condizioni cliniche pregresse, residente nella contea di Grays Harbor, nello Stato di Washington, è risultato positivo all’influenza aviaria in un test preliminare. Lo ha comunicato il Washington State Department of Health, che riferisce l’avvio delle cure e indica un rischio considerato basso per la popolazione.
Un uomo anziano con condizioni cliniche pregresse, residente nella contea di Grays Harbor, nello Stato di Washington, è risultato positivo all’influenza aviaria in un test preliminare. Lo ha comunicato il Washington State Department of Health, che riferisce l’avvio delle cure e indica un rischio considerato basso per la popolazione.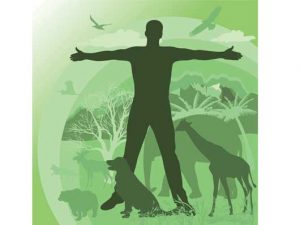 Il parassita della leishmaniosi diventa un vettore per inibire l’Alzheimer. Lo rivela uno studio dell’Università Statale di Milano, pubblicato sul Journal of Neuroinflammation, che dimostra come questo parassita può influenzare il funzionamento delle cellule della microglia, le cellule del cervello coinvolte nella risposta immunitaria: quando queste cellule vengono stimolate con il peptide β-amiloide (una sostanza associata alla malattia di Alzheimer), il parassita riesce a bloccare un importante meccanismo infiammatorio chiamato inflammasoma NLRP3.
Il parassita della leishmaniosi diventa un vettore per inibire l’Alzheimer. Lo rivela uno studio dell’Università Statale di Milano, pubblicato sul Journal of Neuroinflammation, che dimostra come questo parassita può influenzare il funzionamento delle cellule della microglia, le cellule del cervello coinvolte nella risposta immunitaria: quando queste cellule vengono stimolate con il peptide β-amiloide (una sostanza associata alla malattia di Alzheimer), il parassita riesce a bloccare un importante meccanismo infiammatorio chiamato inflammasoma NLRP3.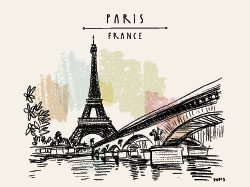 Con l’Accordo di Parigi (dicembre 2015), i Paesi si sono impegnati a elaborare i propri piani di riduzione delle emissioni di gas serra, noti come Contributi determinati a livello nazionale (NDC). Nel loro insieme, questi impegni
Con l’Accordo di Parigi (dicembre 2015), i Paesi si sono impegnati a elaborare i propri piani di riduzione delle emissioni di gas serra, noti come Contributi determinati a livello nazionale (NDC). Nel loro insieme, questi impegni 