Le popolazioni di api mellifere selvatiche dell’Unione Europea sono in pericolo
 Lo stato di conservazione delle popolazioni selvatiche di api mellifere (Apis mellifera) nell’Unione Europea è stato recentemente rivalutato per la Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). La precedente classificazione “Data Deficient” (carenza di dati) è stata aggiornata a “In Pericolo”. Il progetto è stato realizzato da un team di 14 scienziati ed esperti, coordinati dall’associazione internazionale Honey Bee Watch, nell’ambito di uno studio più ampio, la Lista Rossa delle Api Europee, dedicato alla valutazione dello stato di conservazione di quasi 2.000 specie di api.
Lo stato di conservazione delle popolazioni selvatiche di api mellifere (Apis mellifera) nell’Unione Europea è stato recentemente rivalutato per la Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). La precedente classificazione “Data Deficient” (carenza di dati) è stata aggiornata a “In Pericolo”. Il progetto è stato realizzato da un team di 14 scienziati ed esperti, coordinati dall’associazione internazionale Honey Bee Watch, nell’ambito di uno studio più ampio, la Lista Rossa delle Api Europee, dedicato alla valutazione dello stato di conservazione di quasi 2.000 specie di api.
Prima della classificazione “Data Deficient” risalente al 2014, la scarsità di studi sugli alveari selvatici, unita alle prove derivanti dalle minacce che causano la mortalità di quelli gestiti dagli apicoltori, aveva portato scienziati e altri addetti ai lavori a supporre che le popolazioni di api mellifere selvatiche fossero completamente estinte in Europa.
Questa confusione e la mancanza di dati hanno spinto diversi ricercatori ad intraprendere studi sulla prevalenza e la distribuzione di colonie di Apis mellifera che vivono libere, ovvero quelle che scelgono autonomamente il proprio sito di nidificazione, che vivono senza l’intervento umano e il cui studio potrebbe rivelare la presenza di popolazioni selvatiche autosufficienti. Tali alveari sono stati successivamente rinvenuti – e sono attualmente oggetto di studio – in tutta Italia, in Irlanda e Regno Unito, nei parchi nazionali in Francia, nelle foreste di Germania, Svizzera e Polonia, nella capitale della Serbia, Belgrado.
L’aggiornamento allo status “In Pericolo” si applica solo ai 27 Paesi membri dell’UE, ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione con diverse università, istituti di ricerca, associazioni indipendenti, e a studi recenti che hanno fornito una stima del declino delle popolazioni di alveari selvatici. A livello paneuropeo più ampio, lo status rimane invece “Data Deficient” a causa della scarsità di dati sulle popolazioni selvatiche in questa regione più estesa.
Fonte: IZS Venezie
 Sono state pubblicate su Reportnet3, la nuova piattaforma europea di e-Reporting, le versioni finali dei report nazionali sulle Direttive Habitat e Uccelli. I documenti chiudono il ciclo di monitoraggio 2019-2024 e offrono un quadro scientifico aggiornato sullo stato di conservazione del patrimonio naturale italiano, rappresentando uno strumento chiave per la tutela della biodiversità.
Sono state pubblicate su Reportnet3, la nuova piattaforma europea di e-Reporting, le versioni finali dei report nazionali sulle Direttive Habitat e Uccelli. I documenti chiudono il ciclo di monitoraggio 2019-2024 e offrono un quadro scientifico aggiornato sullo stato di conservazione del patrimonio naturale italiano, rappresentando uno strumento chiave per la tutela della biodiversità. È stato formalmente adottato il Programma triennale “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, documento strategico che rafforza l’integrazione tra politiche sanitarie e ambientali e consolida l’approccio One Health nella prevenzione dei rischi ambientali e climatici per la salute.
È stato formalmente adottato il Programma triennale “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, documento strategico che rafforza l’integrazione tra politiche sanitarie e ambientali e consolida l’approccio One Health nella prevenzione dei rischi ambientali e climatici per la salute.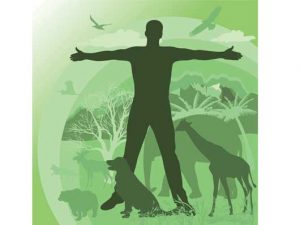 Gli impatti sull’ambiente di vita per le comunità sono rilevanti già ora … Il rapporto clima e salute è immediato. Le comunità ne risentono a secondo della loro ubicazione. È necessario aiutare una loro crescita di consapevolezza e di empowerment. Comunità proattive sono comunità più sane.
Gli impatti sull’ambiente di vita per le comunità sono rilevanti già ora … Il rapporto clima e salute è immediato. Le comunità ne risentono a secondo della loro ubicazione. È necessario aiutare una loro crescita di consapevolezza e di empowerment. Comunità proattive sono comunità più sane. Il mondo è entrato nell’era della bancarotta idrica globale: viviamo in una situazione in cui l’uso e l‘inquinamento delle fonti d’acqua hanno superato le possibilità di rinnovamento e non potranno essere più riportate ai livelli precedenti.
Il mondo è entrato nell’era della bancarotta idrica globale: viviamo in una situazione in cui l’uso e l‘inquinamento delle fonti d’acqua hanno superato le possibilità di rinnovamento e non potranno essere più riportate ai livelli precedenti. L’animale più pericoloso al mondo è sempre più assetato di sangue umano. Detta così potrebbe sembrare l’incipit di un film dell’orrore, ma in realtà c’è un motivo specifico per cui le zanzare scelgono sempre più spesso di nutrirsi del nostro sangue e, guarda caso, è una questione che ha a che fare proprio con le azioni dell’uomo. Con la perdita di biodiversità innescata dalle scelte antropiche le zanzare femmine, in luoghi dove vengono a mancare le foreste e si riducono gli habitat, tendono a causa di meno vertebrati “a disposizione” a preferire l’uomo quando devono nutrirsi. Conclusioni a cui è arrivato un
L’animale più pericoloso al mondo è sempre più assetato di sangue umano. Detta così potrebbe sembrare l’incipit di un film dell’orrore, ma in realtà c’è un motivo specifico per cui le zanzare scelgono sempre più spesso di nutrirsi del nostro sangue e, guarda caso, è una questione che ha a che fare proprio con le azioni dell’uomo. Con la perdita di biodiversità innescata dalle scelte antropiche le zanzare femmine, in luoghi dove vengono a mancare le foreste e si riducono gli habitat, tendono a causa di meno vertebrati “a disposizione” a preferire l’uomo quando devono nutrirsi. Conclusioni a cui è arrivato un  Usati ogni giorno per curare persone e animali, gli antibiotici hanno migliorato la salute pubblica in modo decisivo. Ma una volta utilizzati, una parte di essi finisce inevitabilmente nell’ambiente: attraverso scarichi urbani, acque reflue o residui provenienti dagli allevamenti può infatti raggiungere fiumi, laghi, mari e acque sotterranee, dove i farmaci possono restare a lungo e interagire con gli ecosistemi. A fare il punto su questo fenomeno è una revisione condotta dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM), pubblicata sulla rivista “Science of the Total Environment”.
Usati ogni giorno per curare persone e animali, gli antibiotici hanno migliorato la salute pubblica in modo decisivo. Ma una volta utilizzati, una parte di essi finisce inevitabilmente nell’ambiente: attraverso scarichi urbani, acque reflue o residui provenienti dagli allevamenti può infatti raggiungere fiumi, laghi, mari e acque sotterranee, dove i farmaci possono restare a lungo e interagire con gli ecosistemi. A fare il punto su questo fenomeno è una revisione condotta dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM), pubblicata sulla rivista “Science of the Total Environment”. La velocità con cui scopriamo nuove specie al mondo è decisamente più elevata rispetto ai ritmi che portano all’estinzione delle specie. Questo fatto, oltre alla consapevolezza che ci siano sempre più esemplari di fauna e flora da scoprire, lascia aperta la speranza all’ipotesi che – nonostante l’impatto negativo dell’uomo sulla Terra – la biodiversità di alcuni gruppi di esseri viventi sia ben più ricca di quanto finora immaginata, con vantaggi futuri anche per la salute dell’uomo. Soltanto fino a pochi secoli fa l’umanità non solo non aveva idea di chi, quali e quante fossero le creature con cui stava condividendo la vita sul Pianeta, ma non riusciva nemmeno a identificarle o darle un nome.
La velocità con cui scopriamo nuove specie al mondo è decisamente più elevata rispetto ai ritmi che portano all’estinzione delle specie. Questo fatto, oltre alla consapevolezza che ci siano sempre più esemplari di fauna e flora da scoprire, lascia aperta la speranza all’ipotesi che – nonostante l’impatto negativo dell’uomo sulla Terra – la biodiversità di alcuni gruppi di esseri viventi sia ben più ricca di quanto finora immaginata, con vantaggi futuri anche per la salute dell’uomo. Soltanto fino a pochi secoli fa l’umanità non solo non aveva idea di chi, quali e quante fossero le creature con cui stava condividendo la vita sul Pianeta, ma non riusciva nemmeno a identificarle o darle un nome.