Lo stato dell’alimentazione e dell’agricoltura 2022: sfruttare l’automazione per trasformare i sistemi agroalimentari
 L’automazione agricola, che spazia dai trattori fino all’intelligenza artificiale, può contribuire enormemente a rendere la produzione alimentare più efficiente ed ecologica. Il fatto, tuttavia, che sia sfruttata in maniera disomogenea può addirittura inasprire le disuguaglianze, soprattutto se rimane inaccessibile ai piccoli produttori e ad altri gruppi emarginati, come i giovani e le donne.
L’automazione agricola, che spazia dai trattori fino all’intelligenza artificiale, può contribuire enormemente a rendere la produzione alimentare più efficiente ed ecologica. Il fatto, tuttavia, che sia sfruttata in maniera disomogenea può addirittura inasprire le disuguaglianze, soprattutto se rimane inaccessibile ai piccoli produttori e ad altri gruppi emarginati, come i giovani e le donne.
L’edizione 2022 del rapporto “Lo stato dell’alimentazione e dell’agricoltura” (SOFA), uno dei rapporti faro pubblicati ogni anno dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), esamina in che modo l’automazione nei sistemi agroalimentari può concorrere al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e formula raccomandazioni destinate ai responsabili politici su come ottimizzare i benefici e ridurre al minimo i rischi.
Dai servizi di noleggio di trattori in Ghana fino alle casse di gamberetti che utilizzano l’apprendimento automatico e la robotica in Messico, il rapporto passa in rassegna 27 studi di casi in tutto il mondo, che illustrano tecnologie a vari stadi di sviluppo e capaci di rispondere alle esigenze di aziende agricole di diverse dimensioni e livelli di reddito.
Il rapporto analizza i fattori che muovono lo sviluppo di tali tecnologie e individua alcune barriere che ne ostacolano l’adozione, in particolare, da parte dei piccoli produttori. Alla luce di tale analisi, la pubblicazione suggerisce politiche per garantire che l’automazione agricola sia inclusiva e contribuisca alla creazione di sistemi agroalimentari sostenibili e resilienti.
Infine, il rapporto esamina anche uno dei più frequenti timori legati all’automazione, ossia la possibilità che essa crei disoccupazione, concludendo che tali preoccupazioni non sono supportate dai fatti.
Al contrario, secondo il rapporto, l’automazione, in generale, riduce la carenza di manodopera e può rendere la produzione agricola più resiliente e dinamica, migliorare la qualità dei prodotti, accrescere l’efficienza nell’uso delle risorse, promuovere un’occupazione dignitosa e incrementare la sostenibilità ambientale.
“La FAO è realmente convinta che, senza il progresso tecnologico e un aumento della produttività, non sia possibile affrancare centinaia di milioni di persone dalla povertà, dalla fame, dall’insicurezza alimentare e dalla malnutrizione,” scrive il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, nella prefazione al rapporto. “Il nocciolo della questione è capire, non tanto se l’automazione troverà o meno applicazione in agricoltura, quanto in che modo essa sia portata avanti nella pratica. Dobbiamo, cioè, garantire che l’automazione dei processi produttivi avvenga in maniera inclusiva e tale da promuovere la sostenibilità.”
Progressi nel campo dell’automazione
Fin dall’antichità, gli esseri umani hanno cercato di ridurre la fatica del lavoro agricolo sviluppando strumenti ingegnosi e sfruttando la forza del fuoco, del vento, dell’acqua e degli animali. Nel 4000 a.C., gli agricoltori mesopotamici utilizzavano già l’aratro trainato da buoi, mentre i primi mulini idraulici hanno fatto la loro comparsa, in Cina, intorno al 1000 a.C.
Negli ultimi due secoli, il ritmo del cambiamento tecnologico ha subito una drastica accelerazione, innescata dalla scoperta del motore a vapore e, successivamente, sostenuta dall’avvento dei trattori alimentati da combustibili fossili.
Al giorno d’oggi, è in corso una nuova rivoluzione, che è guidata dalle tecnologie digitali. Tra queste, si annoverano l’intelligenza artificiale, i droni, la robotica, i sensori e i sistemi satellitari globali di navigazione, accanto alla vasta proliferazione di dispositivi portatili, come i cellulari e un’infinità di nuovi dispositivi collegati a Internet, il cosiddetto Internet delle cose. Un altro importante sviluppo riguarda l’ambito dell’economia della condivisione. In Africa e in Asia, per esempio, i servizi di beni condivisi adottano un modello simile all’applicazione dei taxi Uber, che permette agli agricoltori di piccole e medie dimensioni di accedere a macchinari costosi, come un trattore, senza doverli necessariamente acquistare.
L’enorme disparità che si osserva nella diffusione dell’automazione tra vari paesi e all’interno degli stessi è un fattore cruciale, soprattutto nelle regioni, come l’Africa subsahariana, dove l’adozione di tali strumenti è particolarmente limitata. Per esempio, già nel 2005, si calcolava che in Giappone erano disponibili oltre 400 trattori per 1 000 ettari di terra arabile, rispetto agli appena 0,4 trattori presenti in Ghana.
Alcune tecnologie, inoltre, sono ancora in fase di prototipazione, mentre la diffusione di altre è ostacolata da scarse infrastrutture di appoggio (come la connettività e l’elettricità), soprattutto nei paesi a basso e medio reddito.
È bene, infine, ricordare che alcune tecnologie, come i grandi macchinari motorizzati, possono avere effetti ambientali negativi, poiché contribuiscono alla monocultura e all’erosione del suolo. Ad ogni modo, la recente diffusione di macchinari di più piccole dimensioni sta aiutando a superare tali criticità.
Raccomandazioni politiche
Il principio cardine su cui poggiano le raccomandazioni politiche formulate nel rapporto ruota attorno all’idea di un cambiamento tecnologico responsabile. Tale prospettiva comporta, per un verso, la necessità di prevedere l’impatto delle tecnologie sulla produttività, la resilienza e la sostenibilità, e, per un altro verso, la disponibilità a concentrarsi sui gruppi vulnerabili ed emarginati.
La chiave di volta consiste nel creare un contesto favorevole, che presupponga un uso coerente di vari strumenti politici contemporaneamente, tra cui norme e regolamenti, infrastrutture, accordi istituzionali, istruzione e formazione, ricerca e sviluppo, e il sostegno ai processi d’innovazione del settore privato.
Tra gli impegni presi per ridurre una diffusione disomogenea dell’automazione dovrebbero esserci gli investimenti inclusivi, con la partecipazione di produttori, fabbricanti e fornitori di servizi, in particolare giovani e donne, allo scopo ultimo di sviluppare ulteriormente le tecnologie e adattarle alle esigenze specifiche degli utenti finali.
Inoltre, gli investimenti e altre azioni politiche concepite per promuovere un’automazione responsabile in ambito agricolo dovrebbero tener conto delle condizioni specifiche di una determinata area, come lo stato della connettività, le sfide legate alle conoscenze e alle competenze, l’adeguatezza delle infrastrutture e le disparità di accesso. Anche le condizioni biofisiche, topografiche e climatiche giocano un ruolo in tal senso. Per esempio, piccoli macchinari e addirittura gli strumenti manuali possono offrire benefici sostanziali ai piccoli produttori che lavorano i terreni collinari.
Infine, il rapporto prende in esame i diffusi timori per i possibili impatti negativi delle tecnologie che semplificano il lavoro, in termini di disoccupazione e trasferimento dei posti di lavoro. Pur concludendo che tali timori sono eccessivi, il rapporto riconosce che l’automazione in agricoltura può effettivamente generare disoccupazione nelle zone in cui la manodopera rurale è abbondante e i salari sono bassi.
In tali zone ad alta intensità di manodopera, i responsabili politici dovrebbero evitare di incentivare l’automazione e concentrarsi piuttosto sulla creazione di un contesto favorevole per la sua adozione, offrendo, al tempo stesso, forme di protezione sociale ai lavoratori meno qualificati, che hanno maggiori probabilità di perdere il lavoro durante la transizione.
Definizioni
Con il termine automazione agricola nel rapporto si intende il ricorso a macchinari e attrezzature nelle attività agricole per migliorare la diagnosi, il processo decisionale o le prestazioni, riducendo la fatica del lavoro agricolo e/o migliorando la tempestività, nonché potenzialmente la precisione, delle operazioni agricole.
Con l’espressione sistemi agroalimentari si intende l’intera gamma di attori, nonché le attività generatrici di valore aggiunto ad essi correlate, coinvolti nella produzione primaria di alimenti e prodotti agricoli non alimentari, nonché nello stoccaggio, nell’aggregazione, nel trattamento post-raccolta, nel trasporto, nella lavorazione, nella distribuzione, nella commercializzazione, nello smaltimento e nel consumo di tutti i prodotti alimentari, compresi i prodotti di origine non agricola.
 Dal monitoraggio costante la scoperta del nuovo virus del pipistrello in Lombardia
Dal monitoraggio costante la scoperta del nuovo virus del pipistrello in Lombardia Il 27 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
Il 27 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 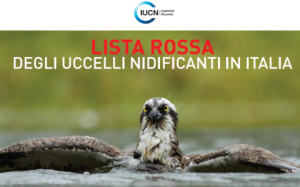 I dati aggiornati al 2021 fanno seguito alla valutazione del 2012
I dati aggiornati al 2021 fanno seguito alla valutazione del 2012
 Nei laboratori europei non si stanno sperimentando solo le
Nei laboratori europei non si stanno sperimentando solo le  Per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita in maniera sostenibile dovremmo allevare i roditori? Ne parla un articolo di Giovanni Ballarini su
Per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita in maniera sostenibile dovremmo allevare i roditori? Ne parla un articolo di Giovanni Ballarini su  Dal pesce scorpione grigliato, all’antipasto a base del pesce coniglio, al granchio blu al vapore, una specie quest’ultima molto diffusa e apprezzata in Italia, tanto da pensare alla creazione di una vera e propria filiera.
Dal pesce scorpione grigliato, all’antipasto a base del pesce coniglio, al granchio blu al vapore, una specie quest’ultima molto diffusa e apprezzata in Italia, tanto da pensare alla creazione di una vera e propria filiera. Gli insetti hanno le potenzialità per diventare un’importante fonte alimentare sia per l’alimentazione animale che umana nel mondo Occidentale, ma con quali garanzie per la salute della specie e la sicurezza alimentare? Una revisione sistematica condotta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha individuato più di 70 specie di virus presenti negli insetti commestibili allevati, per la maggior parte non patogeni né per gli insetti né per l’uomo. Esistono però dei virus, specifici degli insetti, capaci di infettare e causare malattia e portare alla morte in breve tempo intere colonie di insetti allevati. Il rischio di trasmettere all’uomo virus di origine alimentare tramite insetti edibili è considerato basso, essendo al momento attributo loro solo un ruolo meccanico nella diffusione di patogeni. Dato il numero limitato di studi presenti finora in letteratura, lo studio IZSVe suggerisce la necessità di investire in ricerca e biosicurezza.
Gli insetti hanno le potenzialità per diventare un’importante fonte alimentare sia per l’alimentazione animale che umana nel mondo Occidentale, ma con quali garanzie per la salute della specie e la sicurezza alimentare? Una revisione sistematica condotta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha individuato più di 70 specie di virus presenti negli insetti commestibili allevati, per la maggior parte non patogeni né per gli insetti né per l’uomo. Esistono però dei virus, specifici degli insetti, capaci di infettare e causare malattia e portare alla morte in breve tempo intere colonie di insetti allevati. Il rischio di trasmettere all’uomo virus di origine alimentare tramite insetti edibili è considerato basso, essendo al momento attributo loro solo un ruolo meccanico nella diffusione di patogeni. Dato il numero limitato di studi presenti finora in letteratura, lo studio IZSVe suggerisce la necessità di investire in ricerca e biosicurezza.