Il mondo e’ Donna!
 Mentre non sussistono dubbi in merito al fatto che la tragica morte di una brillante Studentessa in Ingegneria Biomedica qual’era perlappunto Giulia Cecchettin, così come i tanti, troppi femminicidi (2 a settimana in media!) che da tanti, troppi anni si registrano nel nostro Paese richiedano un radicale e non più procrastinanabile cambio di paradigma, soprattutto culturale, la cui fondamentale premessa appare costituita da una capillare quanto permanente e diffusa opera di educazione sessuale, affettiva e sentimentale a partire dai fanciulli e dalle fanciulle in tenera età scolare, ritengo doveroso esternare e condividere alcune riflessioni.
Mentre non sussistono dubbi in merito al fatto che la tragica morte di una brillante Studentessa in Ingegneria Biomedica qual’era perlappunto Giulia Cecchettin, così come i tanti, troppi femminicidi (2 a settimana in media!) che da tanti, troppi anni si registrano nel nostro Paese richiedano un radicale e non più procrastinanabile cambio di paradigma, soprattutto culturale, la cui fondamentale premessa appare costituita da una capillare quanto permanente e diffusa opera di educazione sessuale, affettiva e sentimentale a partire dai fanciulli e dalle fanciulle in tenera età scolare, ritengo doveroso esternare e condividere alcune riflessioni.
La prima, da cittadino di un Paese la cui popolazione generale d’età compresa fra 18 e 65 anni risulterebbe affetta da una condizione di analfabetismo totale (5%), di semi-analfabetismo (33%) o di analfabetismo “di ritorno” (alias “funzionale”), per un totale di circa 30 milioni di nostri connazionali (la metà degli abitanti complessivi!) interessati da una delle tre succitate fattispecie.
La seconda, da professore universitario in pensione, che per quasi 20 anni ha valutato le prove d’esame di tante ragazze e ragazzi frequentanti il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, riscontrando performance ben più soddisfacenti nella popolazione studentesca femminile rispetto a quella maschile.
La terza, riguardante la sperequazione salariale esistente fra uomini e donne che si trovino a svolgere analoghe attività lavorative e/o che abbiano identiche responsabilità professionali, criticità quest’ultima che a onor del vero caratterizza non soltanto la vita sociale del nostro Paese, ma anche quella di molte altre Nazioni, europee e non, a fronte di talenti, competenze e capacità professionali che in molti casi ed in molti settori vedono le donne sopravanzare i loro colleghi maschi.
Da ciò deriverebbe, peraltro, il senso di frustrazione permeante l’esistenza di certi nostri connazionali di sesso maschile, stanti gli atavici retaggi culturali in nome dei quali podestà e potere sarebbero sempre e comunque esercitati dai maschi.
Il mondo e’ Donna, diceva a ragione e non a caso il grande Federico Fellini!
Giovanni Di Guardo
Già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo
 Alle ultime riunioni EFSA del gruppo di discussione degli stakeholder sui rischi emergenti (StaDG-ER, 9 novembre, Bruxelles) e EREN (Emerging Risk Exchange Network, 22 novembre Parma) Maurizio Ferri, coordinatore scientifico SIMeVeP, ha relazionato sul tema dei rischi per la sanità pubblica delle diete a base di carne cruda (o BARF) per cani e gatti.
Alle ultime riunioni EFSA del gruppo di discussione degli stakeholder sui rischi emergenti (StaDG-ER, 9 novembre, Bruxelles) e EREN (Emerging Risk Exchange Network, 22 novembre Parma) Maurizio Ferri, coordinatore scientifico SIMeVeP, ha relazionato sul tema dei rischi per la sanità pubblica delle diete a base di carne cruda (o BARF) per cani e gatti. Si terrà ad Arezzo dal 21 al 24 novembre, con il patrocinio di SIMeVeP e SIVeMP, la 18ª edizione del Forum Risk Management “La sfida della sanità pubblica. Cambiamento – Sostenibilità – Prossimità.
Si terrà ad Arezzo dal 21 al 24 novembre, con il patrocinio di SIMeVeP e SIVeMP, la 18ª edizione del Forum Risk Management “La sfida della sanità pubblica. Cambiamento – Sostenibilità – Prossimità.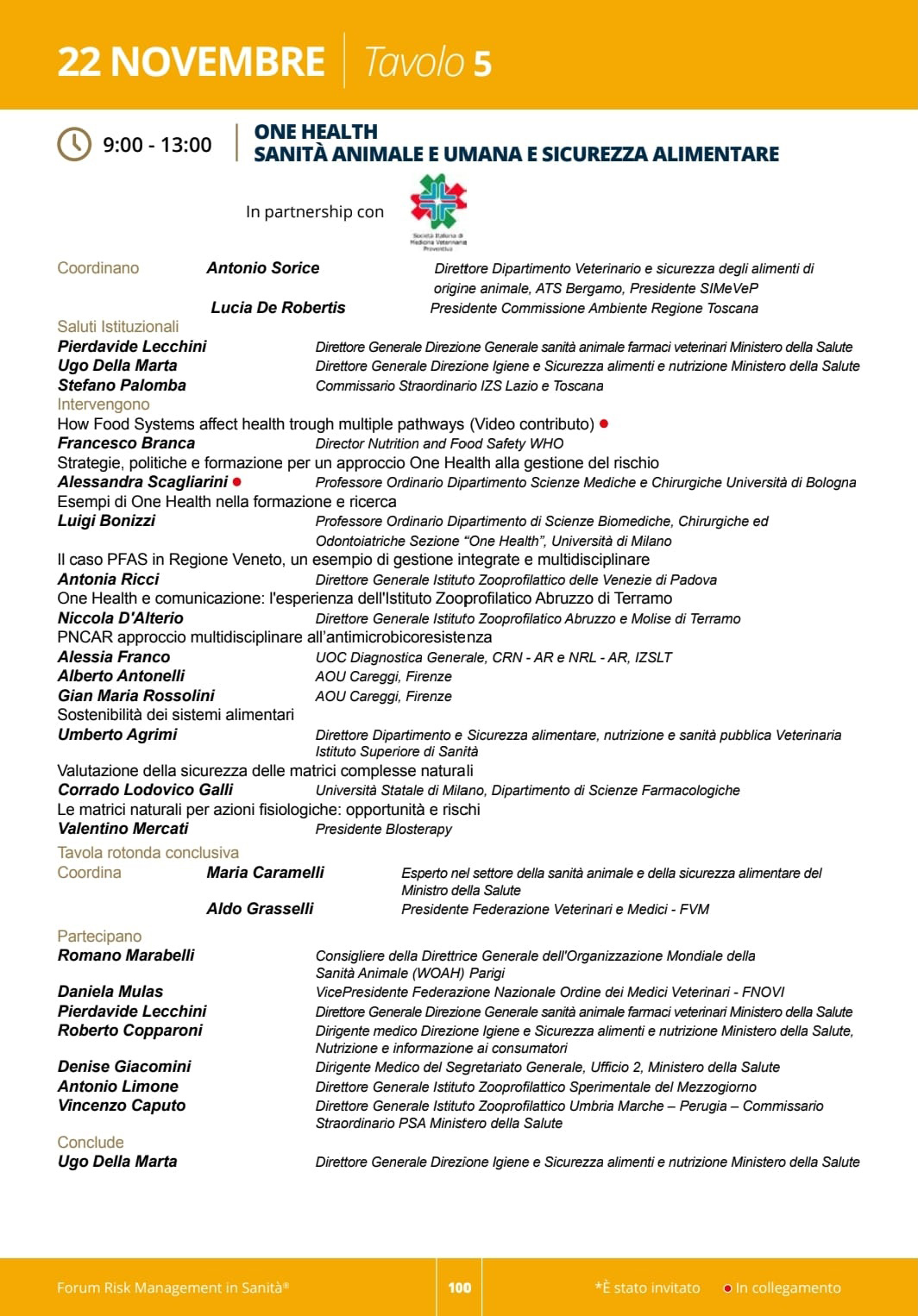
 E’ da oltre mezzo secolo che l’Italia fa i conti, ahime/ahinoi, con la cosiddetta “fuga dei cervelli”, una drammatica emorragia di brillanti intelligenze e di preziose competenze che, una volta formatesi nelle nostre università, vanno a rendere ancor più prospera e rigogliosa l’economia e la società dei Paesi che le accolgono, in larga misura europei.
E’ da oltre mezzo secolo che l’Italia fa i conti, ahime/ahinoi, con la cosiddetta “fuga dei cervelli”, una drammatica emorragia di brillanti intelligenze e di preziose competenze che, una volta formatesi nelle nostre università, vanno a rendere ancor più prospera e rigogliosa l’economia e la società dei Paesi che le accolgono, in larga misura europei. Cambio della guardia alla guida del Gruppo di Lavoro SIMeVeP “Filiere fragili e produzioni locali”, il GdL nato per impulso di Raffaella Moretti con l’intento di fare il punto circa il sistema dei controlli in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e la conseguente sua applicazione, ispirata ai principi di flessibilità previsti dalla vigente normativa, nelle produzioni animali e agroalimentari sostenibili e di nicchia, anche dette piccole produzioni locali che rappresentano le unità costituenti delle c.d. filiere fragili.
Cambio della guardia alla guida del Gruppo di Lavoro SIMeVeP “Filiere fragili e produzioni locali”, il GdL nato per impulso di Raffaella Moretti con l’intento di fare il punto circa il sistema dei controlli in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e la conseguente sua applicazione, ispirata ai principi di flessibilità previsti dalla vigente normativa, nelle produzioni animali e agroalimentari sostenibili e di nicchia, anche dette piccole produzioni locali che rappresentano le unità costituenti delle c.d. filiere fragili. Una delle sfide che il mondo deve affrontare è quella di garantire cibo sufficiente per la popolazione, che si prevede raggiungerà 9-11 miliardi nel 2050. Secondo un rapporto della FAO per soddisfare il futuro fabbisogno alimentare, la produzione mondiale di carne dovrà essere più che raddoppiata, passando da 229 milioni di tonnellate nel 1999/2001 a 465 milioni di tonnellate entro il 2050. La stessa organizzazione stima che con la crescita della popolazione e l’aumento dei redditi medi la domanda globale di prodotti di origine animale aumenterà fino al 70% tra il 2010 e il 2050, mentre la carne fino al 15% entro il 2031 3 con effetti sulla salute, risorse ed ambiente.
Una delle sfide che il mondo deve affrontare è quella di garantire cibo sufficiente per la popolazione, che si prevede raggiungerà 9-11 miliardi nel 2050. Secondo un rapporto della FAO per soddisfare il futuro fabbisogno alimentare, la produzione mondiale di carne dovrà essere più che raddoppiata, passando da 229 milioni di tonnellate nel 1999/2001 a 465 milioni di tonnellate entro il 2050. La stessa organizzazione stima che con la crescita della popolazione e l’aumento dei redditi medi la domanda globale di prodotti di origine animale aumenterà fino al 70% tra il 2010 e il 2050, mentre la carne fino al 15% entro il 2031 3 con effetti sulla salute, risorse ed ambiente. Nel solo triennio 2017-2019 sono state ben 70 le creature aliene censite nel Mediterraneo, fra le quali si segnalano in particolare Callinectes sapidus e Portunus segnis, due specie di granchio blu che stanno diffusamente colonizzando il Mare Adriatico. Originarie rispettivamente dalle coste atlantiche del Nord-America e da quelle africane dell’Oceano Indiano, la loro principale fonte di nutrimento e’ costituita da mitili e vongole, di cui sono pressoché insaziabili predatori.
Nel solo triennio 2017-2019 sono state ben 70 le creature aliene censite nel Mediterraneo, fra le quali si segnalano in particolare Callinectes sapidus e Portunus segnis, due specie di granchio blu che stanno diffusamente colonizzando il Mare Adriatico. Originarie rispettivamente dalle coste atlantiche del Nord-America e da quelle africane dell’Oceano Indiano, la loro principale fonte di nutrimento e’ costituita da mitili e vongole, di cui sono pressoché insaziabili predatori. Domani, 5 settembre, arriverà in Conferenza Stato Regioni “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)” già approvato dalla Commissione Agricoltura della Conferenza.
Domani, 5 settembre, arriverà in Conferenza Stato Regioni “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)” già approvato dalla Commissione Agricoltura della Conferenza. Si è svolto ieri presso il ministero della Salute, l’incontro scientifico “L’antimicrobico resistenza: una minaccia globale”, prima iniziativa della seconda edizione del progetto “La Sanità che vorrei” promosso dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali, in collaborazione con altre società scientifiche e associazioni di pazienticon l’obiettivo di favorire i processi di prevenzione e formazione sul tema dell’antibiotico-resistenza e le Ica, ossia le infezioni correlate all’assistenza.
Si è svolto ieri presso il ministero della Salute, l’incontro scientifico “L’antimicrobico resistenza: una minaccia globale”, prima iniziativa della seconda edizione del progetto “La Sanità che vorrei” promosso dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali, in collaborazione con altre società scientifiche e associazioni di pazienticon l’obiettivo di favorire i processi di prevenzione e formazione sul tema dell’antibiotico-resistenza e le Ica, ossia le infezioni correlate all’assistenza.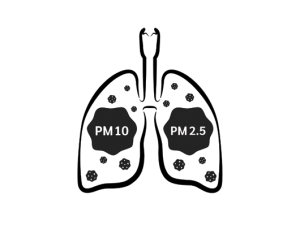 I risultati del progetto EpiCovAir su inquinamento atmosferico e COVID-19
I risultati del progetto EpiCovAir su inquinamento atmosferico e COVID-19