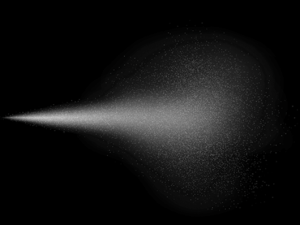 Anche il 2023 non ha smentito la triste fama dell’ottennio (2015-2022) che l’ha preceduto, caratterizzandosi giustappunto come il più caldo degli ultimi 140 anni (Witze, 2024)!
Anche il 2023 non ha smentito la triste fama dell’ottennio (2015-2022) che l’ha preceduto, caratterizzandosi giustappunto come il più caldo degli ultimi 140 anni (Witze, 2024)!
Tra i numerosi fattori che sono alla base di un siffatto, allarmante fenomeno le aumentate concentrazioni di gas serra (anidride carbonica e metano, in primis) nell’atmosfera giocano senza alcun dubbio un ruolo di primaria importanza, atteso che mai prima d’ora erano stati registrati livelli così alti di CO2 (Witze, 2024).
Di pari passo con l’innalzamento delle temperature medie globali stiamo assistendo ad un progressivo, preoccupante incremento di eventi meteo-climatici estremi, rispetto ai quali siccità ed alluvioni (come quelle verificatesi lo scorso anno in Emilia-Romagna ed in Toscana) rappresentano due facce della stessa medaglia.
Dell’innalzamento delle temperature medie globali potrebbero plausibilmente approfittare una serie di microorganismi patogeni, virali e non, notoriamente dotati di un’elevata resistenza ambientale, nel cui novero andrebbero senz’altro inclusi i due DNA-virus del vaiolo delle scimmie (Monkeypox Virus, Mpx) – già classificato ad opera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità come un agente responsabile di una “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” (“public health emergency of international concern“, PHEIC) (Rheinbaben et al, 2007) – e della peste suina africana, che nel recente passato ha provocato e sta tuttora determinando ingentissimi danni agli allevamenti ed all’industria suinicola di molti Paesi (Mazur-Panasiuk et al., 2019), nonché i prioni – responsabili dell’encefalopatia spongiforme bovina, alias “morbo della mucca pazza”, l’unica malattia prionica a carattere zoonosico, cioè trasmissibile dagli animali all’uomo (Di Guardo, 2015) – e numerosi batteri sporigeni, quali Bacillus anthracis, Clostridium tetani e C. botulinum.
In un siffatto contesto, la possibilità che i venti, le correnti ed altri fattori metereologici possano veicolare i succitati agenti patogeni (ed altri ancora, accomunati agli stessi da un’elevata resistenza nei confronti dell’inattivazione chimico-fisica) a distanza, anche notevole, rispetto al sito in cui uno o più ospiti infetti li avessero eliminati dovrebbe essere tenuta in debita considerazione.
A tal proposito, infatti, numerosi studi condotti nel corso degli ultimi decenni hanno chiaramente dimostrato che gli aerosol originanti dai mari e dagli oceani (“sea spray aerosols“) presentano una composizione ben più complessa di quella immaginata (ovvero salina), dal momento che al proprio interno ospiterebbero un miscuglio di molecole proteiche, enzimi, acidi grassi e zuccheri, oltre ad una flora microbica composta da svariati agenti di natura batterica e virale (Schiffer et al., 2018).
Ne deriva che l’inclusione (anche) degli aerosol tra i fattori di rilevanza eco-epidemiologica nelle indagini finalizzate a chiarire l’origine di focolai di malattie infettive sostenute da agenti dotati di straordinaria resistenza ambientale potrebbe rivelarsi di grande ausilio in tutti quei casi in cui la stessa dovesse apparire indefinita, se non addirittura indecifrabile.
Va da sé, infine, che un siffatto esercizio presuppone una stretta, costante e permanente sinergia fra Medici e Veterinari e, nondimeno, una forte integrazione di competenze e saperi multidisciplinari, in una sana ottica di “One Health”, la salute unica di uomo, animali ed ambiente.
Repetita Iuvant!
Bibliografia
1) Di Guardo G. (2015). Encefalopatie Spongiformi Transmissibili. In: Marcato P.S. Patologia Sistematica Veterinaria, Seconda Edizione, Edagricole-Il Sole 24 Ore, Bologna.
2) Mazur-Panasiuk N., Żmudzki J., Woźniakowski G. African Swine Fever Virus: Persistence in Different Environmental Conditions and the Possibility of its Indirect Transmission (2019). J. Vet. Res. 13;63(3):303-310. doi: 10.2478/jvetres-2019-0058.
3) Rheinbaben F.V. Gebel J., Exner M., Schmidt A. (2007). Environmental resistance, disinfection, and sterilization of poxviruses. In: Mercer A.A., Schmidt A., Weber O. (Eds.) Poxviruses. Birkhäuser Advances in Infectious Diseases. Birkhäuser Basel. https://doi.org/10.1007/978-3-7643-7557-7_19.
4) Schiffer J.M., Mael L.E.,Prather K.A., Amaro R.E., Grassian V.H. (2018). Sea spray aerosol: Where marine biology meets atmospheric chemistry. ACS Central Science 4(12):1617-1623.
Giovanni Di Guardo, DVM, Dipl. ECVP,
Già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo
 Con Decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 22 dicembre 2023 è stato istituito il “Tavolo tecnico per la definizione di obiettivi, standard organizzativi e di personale dei Dipartimenti di Prevenzione finalizzato alla “definizione di obiettivi, standard organizzativi e di personale dei dipartimenti di prevenzione, alla luce del nuovo assetto della prevenzione collettiva e di sanità pubblica previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Con Decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 22 dicembre 2023 è stato istituito il “Tavolo tecnico per la definizione di obiettivi, standard organizzativi e di personale dei Dipartimenti di Prevenzione finalizzato alla “definizione di obiettivi, standard organizzativi e di personale dei dipartimenti di prevenzione, alla luce del nuovo assetto della prevenzione collettiva e di sanità pubblica previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Il drammatico crollo delle vaccinazioni di massa della popolazione pediatrica nei confronti del morbillo, registratosi in piena pandemia da COVID-19 in Italia cosi come in Europa e nel resto del mondo, ha gia provocato nel 2022, rispetto all’anno precedente, un incremento pari al 18% dei casi e al 43% delle morti conseguenti alla malattia. Al di la’ delle fin troppo ovvie ricadute che ciò esercita sul controllo di una malattia che causa ancora, a tutt’oggi, non meno di 100.000 decessi su scala globale, andrebbe adeguatamente sottolineato che le vaccinazioni di massa nei confronti del morbillo avrebbero scongiurato, fra il 2000 e il 2021, ben 57 milioni di decessi (Minta et al., 2023)!
Il drammatico crollo delle vaccinazioni di massa della popolazione pediatrica nei confronti del morbillo, registratosi in piena pandemia da COVID-19 in Italia cosi come in Europa e nel resto del mondo, ha gia provocato nel 2022, rispetto all’anno precedente, un incremento pari al 18% dei casi e al 43% delle morti conseguenti alla malattia. Al di la’ delle fin troppo ovvie ricadute che ciò esercita sul controllo di una malattia che causa ancora, a tutt’oggi, non meno di 100.000 decessi su scala globale, andrebbe adeguatamente sottolineato che le vaccinazioni di massa nei confronti del morbillo avrebbero scongiurato, fra il 2000 e il 2021, ben 57 milioni di decessi (Minta et al., 2023)! La Commissione europea ha bocciato la notifica della legge italiana che vieta la carne coltivata per violazione del diritto Ue. In sostanza, dopo la notifica del testo alla Commissione il 1 Dicembre, (che ricordiamo era stato approvato in Parlamento come disegno di legge il 16 Novembre scorso) come prevede la procedura Tris, il Governo non ha rispettato il periodo di sospensione di 3 mesi durante il quale la Commissione è tenuta a verificare la compatibilità del testo con le norme del mercato interno (parere circostanziato) e si è affrettato a richiedere l’approvazione definitiva della legge che è stata promulgata proprio il 1 Dicembre.
La Commissione europea ha bocciato la notifica della legge italiana che vieta la carne coltivata per violazione del diritto Ue. In sostanza, dopo la notifica del testo alla Commissione il 1 Dicembre, (che ricordiamo era stato approvato in Parlamento come disegno di legge il 16 Novembre scorso) come prevede la procedura Tris, il Governo non ha rispettato il periodo di sospensione di 3 mesi durante il quale la Commissione è tenuta a verificare la compatibilità del testo con le norme del mercato interno (parere circostanziato) e si è affrettato a richiedere l’approvazione definitiva della legge che è stata promulgata proprio il 1 Dicembre. Veterinary Research, una delle riviste più prestigiose nell’ambito della veterinaria, ha pubblicato lo scorso mese di dicembre un lavoro a cura dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna dal titolo “Streptococcus ruminantium-associated sheep mastitis outbreak detected in Italy is distinct from bovine isolates”. La ricerca è stata proposta come “featured article”(articolo in evidenza) nella Homepage della rivista.
Veterinary Research, una delle riviste più prestigiose nell’ambito della veterinaria, ha pubblicato lo scorso mese di dicembre un lavoro a cura dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna dal titolo “Streptococcus ruminantium-associated sheep mastitis outbreak detected in Italy is distinct from bovine isolates”. La ricerca è stata proposta come “featured article”(articolo in evidenza) nella Homepage della rivista. Arrivato il via libera dalla Commissione nazionale formazione continua dell’Agenas. La Fad ha visto una crescita pari al 40% nei due anni coincidenti con il periodo emergenziale. In diminuzione la formazione residenziale
Arrivato il via libera dalla Commissione nazionale formazione continua dell’Agenas. La Fad ha visto una crescita pari al 40% nei due anni coincidenti con il periodo emergenziale. In diminuzione la formazione residenziale Il 1° gennaio 2024 l’Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7: il gruppo che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America. Il G7, al quale partecipa anche l’Unione Europea, è unito da valori e principi comuni e ricopre un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali.
Il 1° gennaio 2024 l’Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7: il gruppo che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America. Il G7, al quale partecipa anche l’Unione Europea, è unito da valori e principi comuni e ricopre un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali.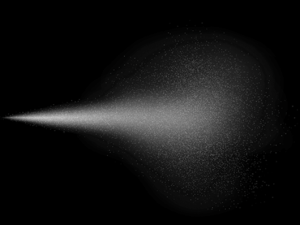 Anche il 2023 non ha smentito la triste fama dell’ottennio (2015-2022) che l’ha preceduto, caratterizzandosi giustappunto come il più caldo degli ultimi 140 anni (Witze, 2024)!
Anche il 2023 non ha smentito la triste fama dell’ottennio (2015-2022) che l’ha preceduto, caratterizzandosi giustappunto come il più caldo degli ultimi 140 anni (Witze, 2024)!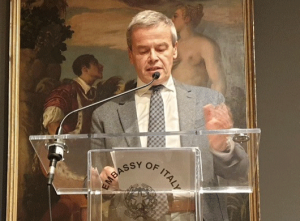 Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha conferito al Direttore generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della Salute, Ugo Della Marta, le funzioni di Capo dei Servizi Veterinari italiani (Chief Veterinary Officer – CVO).
Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha conferito al Direttore generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della Salute, Ugo Della Marta, le funzioni di Capo dei Servizi Veterinari italiani (Chief Veterinary Officer – CVO). L’e-commerce alimentare, ossia la vendita di alimenti online, ha raggiunto, per ovvie ragioni, il suo culmine con la pandemia CoVID-19. Attualmente, per svariati motivi attinenti, ad esempio la comodità e celerità nonché la modernità e i nuovi costumi nell’approvvigionamento degli alimenti, l’e-commerce mantiene un suo interesse tra determinate fasce di consumatori. La modalità di vendita online, se da un lato si è rivelata subito efficace sia per l’OFA (Operatore della Filiera Agroalimentare) sia per il consumatore finale, grazie a diversi aspetti vantaggiosi che ne hanno consentito una rapida diffusione quali l’assenza di barriere geografiche e di orari, i costi operativi bassi, l’inventario semplice da automatizzare, la facilità d’acquisto, la vasta gamma di prodotti partendo da quelli più commerciali a quelli di “nicchia”, comprendendo alimenti sia freschi sia secchi, dall’altro è stata individuata da numerose imprese alimentari quale strumento per eludere obblighi normativi come il riconoscimento comunitario.
L’e-commerce alimentare, ossia la vendita di alimenti online, ha raggiunto, per ovvie ragioni, il suo culmine con la pandemia CoVID-19. Attualmente, per svariati motivi attinenti, ad esempio la comodità e celerità nonché la modernità e i nuovi costumi nell’approvvigionamento degli alimenti, l’e-commerce mantiene un suo interesse tra determinate fasce di consumatori. La modalità di vendita online, se da un lato si è rivelata subito efficace sia per l’OFA (Operatore della Filiera Agroalimentare) sia per il consumatore finale, grazie a diversi aspetti vantaggiosi che ne hanno consentito una rapida diffusione quali l’assenza di barriere geografiche e di orari, i costi operativi bassi, l’inventario semplice da automatizzare, la facilità d’acquisto, la vasta gamma di prodotti partendo da quelli più commerciali a quelli di “nicchia”, comprendendo alimenti sia freschi sia secchi, dall’altro è stata individuata da numerose imprese alimentari quale strumento per eludere obblighi normativi come il riconoscimento comunitario. Dopo il Regno Unito e la Spagna ora anche il Governo tedesco nel suo budget 2024 promuove alternative alla carne con latticini fermentati con tecnologie di precisione, prodotti a base vegetale e carne coltivata.
Dopo il Regno Unito e la Spagna ora anche il Governo tedesco nel suo budget 2024 promuove alternative alla carne con latticini fermentati con tecnologie di precisione, prodotti a base vegetale e carne coltivata.