La resistenza agli antimicrobici nei batteri di origine alimentare continua a destare preoccupazione per la salute pubblica in Europa

Sebbene la resistenza agli antimicrobici comunemente usati rimanga diffusa in batteri di origine alimentare come Salmonella e Campylobacter, diversi Paesi hanno segnalato progressi nella riduzione dei livelli di resistenza nell’uomo e negli animali da produzione alimentare. Poiché questi batteri possono diffondersi dagli animali e dagli alimenti all’uomo causando infezioni gravi che possono richiedere un trattamento antimicrobico, resta fondamentale perseguire azioni continue nel contesto di un approccio One Health.
La resistenza agli antimicrobici nei comuni batteri di origine alimentare rimane elevata
Un’alta percentuale di Campylobacter e Salmonella provenienti sia dall’uomo che dagli animali da produzione alimentare continua a mostrare resistenza alla ciprofloxacina, un importante antimicrobico usato per trattare infezioni gravi nell’uomo. Mentre la resistenza alla ciprofloxacina nella Salmonella proveniente da animali da produzione alimentare è stata costantemente elevata, la resistenza nelle infezioni umane da Salmonella è aumentata negli ultimi anni.
Questa tendenza è preoccupante in quanto la resistenza alla ciprofloxacina limita l’efficacia delle opzioni terapeutiche disponibili. Nel Campylobacter la resistenza è ora così diffusa in Europa che la ciprofloxacina non è più raccomandata per il trattamento delle infezioni umane. Per preservare la continuità della sua efficacia in medicina umana sono state imposte restrizioni al suo uso negli animali.
In tutta Europa un’alta percentuale di Salmonella e Campylobacter provenienti sia dall’uomo che da animali destinati alla produzione di alimenti mostra anche resistenza agli antimicrobici comunemente usati, tra cui ampicillina, tetracicline e sulfamidici.
Inoltre il rilevamento di batteri E. coli produttori di carbapenemasi negli animali da produzione alimentare e nella carne in diversi Paesi richiede grande attenzione. I carbapenemi sono antimicrobici di ultima istanza per l’uomo e non sono autorizzati per l’uso negli animali da produzione alimentare. Il numero di rilevamenti segnalati è in aumento e le loro fonti necessitano di ulteriori indagini.
Fonte: EFSA


 Il rapporto annuale dell’EFSA sui residui di farmaci veterinari negli animali vivi e nei prodotti di origine animale evidenzia anche nel 2024 un’elevata conformità ai limiti di legge.
Il rapporto annuale dell’EFSA sui residui di farmaci veterinari negli animali vivi e nei prodotti di origine animale evidenzia anche nel 2024 un’elevata conformità ai limiti di legge. La Commissione europea ha chiesto all’EFSA di condurre un sondaggio in tutta l’UE, prima e dopo che alcuni Paesi aggiornassero le proprie raccomandazioni sulla frequenza del consumo di pesce e frutti di mare che possono contenere tracce di mercurio.
La Commissione europea ha chiesto all’EFSA di condurre un sondaggio in tutta l’UE, prima e dopo che alcuni Paesi aggiornassero le proprie raccomandazioni sulla frequenza del consumo di pesce e frutti di mare che possono contenere tracce di mercurio.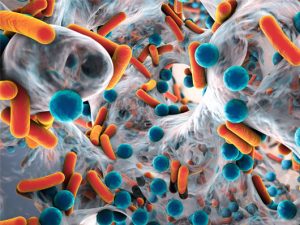 L’eccellenza della sanità veterinaria italiana al servizio della salute pubblica globale: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) sono stati ufficialmente designati Centro di Referenza FAO per la riduzione degli antimicrobici nelle aziende agricole per la trasformazione sostenibile dei sistemi agroalimentari (RENOFARM – Reduce the Need for Antimicrobials on Farms for Sustainable Agrifood Systems Transformation).
L’eccellenza della sanità veterinaria italiana al servizio della salute pubblica globale: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) sono stati ufficialmente designati Centro di Referenza FAO per la riduzione degli antimicrobici nelle aziende agricole per la trasformazione sostenibile dei sistemi agroalimentari (RENOFARM – Reduce the Need for Antimicrobials on Farms for Sustainable Agrifood Systems Transformation). Si terrà il 5 e 6 marzo p.v. il corso dal titolo “IL LUPO TRA CONVIVENZA, TERRITORIO E GESTIONE, i ruoli del Medico Veterinario pubblico e degli altri enti nella verifica dei danni da fauna selvatica tra aspetti istituzionali e medico legali ”. Il corso, patrocinato dalla SIMeVeP, ha ottenuto 23 crediti.
Si terrà il 5 e 6 marzo p.v. il corso dal titolo “IL LUPO TRA CONVIVENZA, TERRITORIO E GESTIONE, i ruoli del Medico Veterinario pubblico e degli altri enti nella verifica dei danni da fauna selvatica tra aspetti istituzionali e medico legali ”. Il corso, patrocinato dalla SIMeVeP, ha ottenuto 23 crediti. La frode del pesce è un fenomeno diffuso a livello mondiale e comprende pratiche ingannevoli che possono compromettere la biodiversità, la salute dei consumatori e l’economia globale. L’ultimo rapporto della FAO, sviluppato in collaborazione con il Centro FAO/IAEA, offre un’analisi approfondita del problema e descrive le tecnologie oggi disponibili per contrastarlo.
La frode del pesce è un fenomeno diffuso a livello mondiale e comprende pratiche ingannevoli che possono compromettere la biodiversità, la salute dei consumatori e l’economia globale. L’ultimo rapporto della FAO, sviluppato in collaborazione con il Centro FAO/IAEA, offre un’analisi approfondita del problema e descrive le tecnologie oggi disponibili per contrastarlo. È tempo di colmare il divario politico tra cambiamento climatico e resistenza antimicrobica. Le due crisi planetarie sono infatti strettamente connesse, ma nonostante questo il cambiamento climatico non è ancora stato integrato nelle politiche esistenti sull’antimicrobicoresistenza (Amr).
È tempo di colmare il divario politico tra cambiamento climatico e resistenza antimicrobica. Le due crisi planetarie sono infatti strettamente connesse, ma nonostante questo il cambiamento climatico non è ancora stato integrato nelle politiche esistenti sull’antimicrobicoresistenza (Amr). Si terrà il 26 marzo a Roma, presso il Ministero della Salute a via Ribotta, il Convegno Nazionale, accreditato ECM, Veterinaria, Ambiente e Cambiamenti Climatici organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP.
Si terrà il 26 marzo a Roma, presso il Ministero della Salute a via Ribotta, il Convegno Nazionale, accreditato ECM, Veterinaria, Ambiente e Cambiamenti Climatici organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con SIVeMP e SIMeVeP.