
Studio dell’IZSVe individua come almeno otto specie di pipistrelli (chirotteri) utilizzino le aree degli allevamenti di suini dell’Italia settentrionale. Sebbene questa interazione possa presentare effetti positivi per entrambe le specie, l’assenza di barriere fisiche e le lacune nella biosicurezza all’interno delle aziende suinicole possono comportare un rischio residuo per la trasmissione inter-specifica di virus.
Legnaro (Padova) – I pipistrelli, o chirotteri, sono riconosciuti come serbatoi naturali di diversi coronavirus (CoV), da alcuni dei quali potrebbero essersi evolute specie virali pericolose per l’uomo e per gli animali domestici, come il SARS-CoV-2 o il virus della diarrea epidemica nel suino. Tuttavia, le dinamiche e i meccanismi che permettono il passaggio di questi virus agli animali da allevamento o all’uomo rimangono per lo più sconosciute.
I ricercatori del Laboratorio di zoonosi virali emergenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) hanno condotto uno studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Plos One, per valutare i fattori di rischio per la trasmissione di virus dai pipistrelli ai suini, usando come caso studio i coronavirus in alcuni allevamenti dell’Italia settentrionale. Lo studio è stato realizzato nell’ambito del progetto europeo ConVErgence e ha visto la collaborazione dell’Università La Sapienza di Roma, Università di Padova, Università di Bari, Università del Sussex (UK) e Coop. STERNA di Forlì.
“L’interfaccia fra animali selvatici, animali domestici ed esseri umani, rappresenta un confine molto labile dove possono emergere malattie infettive a carattere epidemico”, spiega Stefania Leopardi, veterinaria dirigente e supervisore della ricerca. “Sappiamo che gli allevamenti suini rappresentano possibili ‘hotspot’ per la diffusione e la comparsa di varianti ricombinanti potenzialmente pericolose per gli animali o l’uomo. Per questo motivo, l’identificazione di nuovi coronavirus è fondamentale per valutare il loro adattamento nel suino e nell’uomo, ma è altrettanto importante cercare di comprendere i fattori di rischio che possono favorire i fenomeni di spillover nelle specie animali.”
Indagini ecologiche, modellistica ambientale, analisi virologiche
Per la ricerca è stato utilizzato un approccio multidisciplinare ispirato al paradigma ‘One Health’, in cui sono state combinate indagini ecologiche, di modellistica ambientale e di virologia molecolare. Una prima fase ha riguardato il monitoraggio bioacustico in 14 allevamenti suinicoli del Triveneto, mediante cui sono state identificate otto specie di pipistrelli negli allevamenti, con P. kuhlii, P. pipistrellus e H. savii come le più diffuse e attive.
L’analisi del paesaggio e delle strutture aziendali ha permesso di identificare i fattori che influenzano maggiormente l’attività dei pipistrelli. È emerso che gli allevamenti con strutture in grado di attrarre insetti registrano un’intensa attività dei pipistrelli, mentre l’habitat circostante incide in misura minore sulla ricchezza delle specie.
Parallelamente, le indagini virologiche hanno permesso di identificare tre nuove specie di CoV, rilevati in P. kuhlii e H. savii, di cui è stato possibile ottenere il sequenziamento completo del genoma. Fondamentale per questa fase l’analisi combinata di campioni raccolti su tre colonie di P. kuhli e di campioni di archivio provenienti da attività di sorveglianza della rabbia in popolazioni di animali selvatici, condotte negli anni dal Laboratorio.
Fra le specie di pipistrello più comuni, è stata osservata una circolazione attiva di CoV in P. kuhlii, anche in colonie situate all’interno delle aziende suinicole, con l’identificazione di due specie distinte di CoV in questi pipistrelli. I CoV sono stati rilevati durante tutta la stagione di attività dei pipistrelli, con picchi a maggio e ad agosto, e in alcuni casi sembrano essere condivisi tra specie diverse di pipistrelli (P. kuhlii e H. savii), aumentando ulteriormente il rischio di ricombinazione genetica.
Le analisi filogenetiche mostrano inoltre che i suini potrebbero essere esposti ad almeno otto specie distinte di CoV, dal momento che i CoV sono associati in modo specifico al proprio ospite.
Da una parte lo studio mette in evidenza come le aziende suinicole possono rappresentare delle oasi per la conservazione dei pipistrelli in ambienti rurali di agricoltura intensiva, dove la monotonia degli elementi ambientali sta inaridendo la biodiversità. In questi ambienti, i pipistrelli possono svolgere un servizio ecosistemico di controllo degli insetti dannosi, anche contribuendo alla riduzione dei pesticidi. Tuttavia, la circolazione dei pipistrelli è anche associata al rischio potenziale di esposizione ai virus che essi veicolano.
Un aspetto fondamentale rilevato dallo studio è la frequente assenza di barriere fisiche negli allevamenti, allestite per impedire il contatto tra i pipistrelli e i recinti dei suini, e un’applicazione disomogenea delle pratiche di biosicurezza. Rafforzare queste misure potrebbe mitigare il rischio di esposizione ai diversi CoV, e più in generale ai virus associati alla fauna selvatica, migliorando la convivenza tra l’uomo e gli animali domestici e selvatici.
Fonte: IZS Venezie
 Cresce la quota di chi non può permettersi per motivi economici di consumare un pasto proteico almeno ogni due giorni (il 9,9% nel 2024, era 8,4% nel 2023), in controtendenza rispetto alla media dell’Unione europea.
Cresce la quota di chi non può permettersi per motivi economici di consumare un pasto proteico almeno ogni due giorni (il 9,9% nel 2024, era 8,4% nel 2023), in controtendenza rispetto alla media dell’Unione europea. Per la prima volta, le api selvatiche sono state ufficialmente classificate come ‘in pericolo’ all’interno dell’Europa: grazie a un grande lavoro di monitoraggio e raccolta dati che ha colmato una lacuna di lunga data, i ricercatori hanno esaminato lo stato di conservazione della specie Apis mellifera in sette paesi europei, stimando un calo medio delle popolazioni selvatiche del 56% in un decennio.
Per la prima volta, le api selvatiche sono state ufficialmente classificate come ‘in pericolo’ all’interno dell’Europa: grazie a un grande lavoro di monitoraggio e raccolta dati che ha colmato una lacuna di lunga data, i ricercatori hanno esaminato lo stato di conservazione della specie Apis mellifera in sette paesi europei, stimando un calo medio delle popolazioni selvatiche del 56% in un decennio.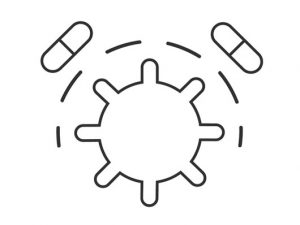 Nel 2023 una persona su sei nel mondo ha contratto un’infezione batterica resistente ai trattamenti antibiotici. È quanto emerge dal nuovo rapporto globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), basato sui dati del sistema di sorveglianza Glass (Global antimicrobial resistance and use surveillance system), che raccoglie informazioni da oltre 100 Paesi.
Nel 2023 una persona su sei nel mondo ha contratto un’infezione batterica resistente ai trattamenti antibiotici. È quanto emerge dal nuovo rapporto globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), basato sui dati del sistema di sorveglianza Glass (Global antimicrobial resistance and use surveillance system), che raccoglie informazioni da oltre 100 Paesi. La sopravvivenza delle api mellifere, fondamentali per l’impollinazione e la sicurezza alimentare globale, è minacciata da Varroa destructor, un acaro parassita che ha rivoluzionato le sfide dell’apicoltura moderna. Un recente studio esplora l’impatto biologico e produttivo dell’infestazione, le strategie di contenimento attuali e le prospettive offerte dall’allevamento selettivo, con un focus sui comportamenti naturali di resistenza che potrebbero rappresentare la chiave per un’apicoltura più sostenibile. Di seguito l’approfondimento.
La sopravvivenza delle api mellifere, fondamentali per l’impollinazione e la sicurezza alimentare globale, è minacciata da Varroa destructor, un acaro parassita che ha rivoluzionato le sfide dell’apicoltura moderna. Un recente studio esplora l’impatto biologico e produttivo dell’infestazione, le strategie di contenimento attuali e le prospettive offerte dall’allevamento selettivo, con un focus sui comportamenti naturali di resistenza che potrebbero rappresentare la chiave per un’apicoltura più sostenibile. Di seguito l’approfondimento. Nelle zampe finte targhette per nasconderne l’origine asiatica ed eludere il divieto di importazione in Europa. I rapaci valgono decine di migliaia di euro.
Nelle zampe finte targhette per nasconderne l’origine asiatica ed eludere il divieto di importazione in Europa. I rapaci valgono decine di migliaia di euro.
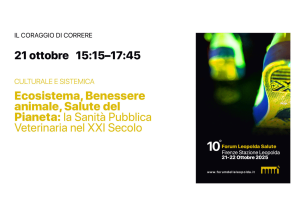 Si terrà il 21 ottobre alla Leopolda Salute a Firenze l’incontro “Ecosistema, Benessere animale, Salute del Pianeta: la Sanità Pubblica Veterinaria nel XXI Secolo”
Si terrà il 21 ottobre alla Leopolda Salute a Firenze l’incontro “Ecosistema, Benessere animale, Salute del Pianeta: la Sanità Pubblica Veterinaria nel XXI Secolo” L’influenza aviaria A (H5N1) è una malattia degli uccelli altamente contagiosa che ha già infettato milioni di uccelli e ora appare in alcuni mammiferi.
L’influenza aviaria A (H5N1) è una malattia degli uccelli altamente contagiosa che ha già infettato milioni di uccelli e ora appare in alcuni mammiferi. Lontano dalla costa, nella pittoresca città universitaria belga di Lovanio, una start-up scommette di poter portare il pesce coltivato in laboratorio sulle tavole degli europei entro il 2030. Nella città portuale tedesca di Amburgo, un’altra start-up si prepara a spedire caviale coltivato in laboratorio a Singapore entro pochi mesi.
Lontano dalla costa, nella pittoresca città universitaria belga di Lovanio, una start-up scommette di poter portare il pesce coltivato in laboratorio sulle tavole degli europei entro il 2030. Nella città portuale tedesca di Amburgo, un’altra start-up si prepara a spedire caviale coltivato in laboratorio a Singapore entro pochi mesi. Un’analisi dei recenti progressi delle strategie emergenti in tempo reale e non distruttive per il monitoraggio della qualità del prodotto e una revisione critica delle conoscenze finora acquisite, anche con l’obiettivo di diminuire gli sprechi.
Un’analisi dei recenti progressi delle strategie emergenti in tempo reale e non distruttive per il monitoraggio della qualità del prodotto e una revisione critica delle conoscenze finora acquisite, anche con l’obiettivo di diminuire gli sprechi.