EFSA, ECDC, EURL: focolai di influenza aviaria in atto nei volatili, basso il rischio per il pubblico
 Continua a evolversi in Europa e a livello mondiale la situazione dell’influenza aviaria: segnalati nuovi focolai nei volatili e infezioni occasionali nei mammiferi. Sporadiche infezioni nell’uomo sono state segnalate in Paesi extra-UE, ma il rischio per la popolazione UE rimane basso. Sono queste alcune delle risultanze evidenziate nell’ultima relazione congiunta sull’influenza aviaria dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e del Laboratorio di riferimento dell’UE (EURL).
Continua a evolversi in Europa e a livello mondiale la situazione dell’influenza aviaria: segnalati nuovi focolai nei volatili e infezioni occasionali nei mammiferi. Sporadiche infezioni nell’uomo sono state segnalate in Paesi extra-UE, ma il rischio per la popolazione UE rimane basso. Sono queste alcune delle risultanze evidenziate nell’ultima relazione congiunta sull’influenza aviaria dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e del Laboratorio di riferimento dell’UE (EURL).
I virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) hanno provocato un aumento di casi di infezione negli uccelli selvatici dell’UE (in particolare nei gabbiani) e continuano a causare infezioni occasionali nei mammiferi. Il numero di focolai infettivi verificatisi nel pollame nell’UE tra dicembre 2022 e marzo 2023 è diminuito dopo il picco del novembre 2022. In Paesi come Francia, Belgio, Paesi Bassi e Italia è stata osservata nei gabbiani un’anomala mortalità di massa. Il rischio di infezioni nel pollame potrebbe aumentare nei prossimi mesi man mano che i gabbiani si spostano verso zone interne, sovrapponendosi eventualmente ad aree di produzione avicola. L’EFSA e l’EURL raccomandano pertanto di mettere in atto strategie di prevenzione nelle zone di produzione avicola.
Sorveglianza dei mammiferi sensibili
In alcuni dei virus circolanti sono state rilevate mutazioni associate ad adattamento genetico ai mammiferi, sia in mammiferi che uccelli. Inoltre recenti episodi di mortalità di massa di mammiferi come i leoni marini suggeriscono una potenziale trasmissione del virus HPAI anche tra i mammiferi. In questo contesto gli scienziati dell’EFSA e dell’EURL raccomandano di estendere e potenziare la sorveglianza ai mammiferi selvatici e d’allevamento, in particolare ai visoni americani e ai suini in quelle zone dove l’HPAI è circolante.
Basso il rischio per la popolazione generale
Anche se sono state segnalate sporadiche infezioni da influenza aviaria nell’uomo, che hanno causato grave malattia o esiti fatali, le infezioni nell’uomo restano un evento raro. La maggior parte delle infezioni gravi riferite nell’uomo di recente da Paesi extraeuropei erano connesse a persone esposte a pollame malato o morto che non avevano indossato dispositivi di protezione individuale, in particolare in piccoli allevamenti privati.
L’ECDC stima che il rischio per il pubblico in Europa sia basso, e da basso a moderato per i lavoratori addetti e altre persone a contatto con volatili e mammiferi morti o malati e potenzialmente infetti. L’ECDC conferma che i virus HPAI attualmente in circolazione sono sensibili ai farmaci antivirali disponibili per l’uomo, e che questi virus si legano di preferenza ai recettori di tipo avicolo presenti negli uccelli e non ai recettori umani.
ECDC, EFSA e EURL raccomandano l’uso appropriato di dispositivi di protezione individuale quando ci si trovi a contatto con volatili. Persone a contatto con volatili o mammiferi infetti devono essere sottoposte ad analisi e tenute sotto controllo onde individuare tempestivamente potenziali casi di trasmissione.
 A tre anni dalla sua esplosione, la pandemia sembra essere finalmente avviata verso la sua coda finale. Tuttavia, se quello che sta accadendo nell’uomo suggerisce un cauto ottimismo, gli esperti invitano a non perdere di vista quello che sta succedendo negli animali, dove il virus Sars-CoV-2 potrebbe trovare nuovi serbatoi e da lì tornare, magari in forma mutata, all’uomo.
A tre anni dalla sua esplosione, la pandemia sembra essere finalmente avviata verso la sua coda finale. Tuttavia, se quello che sta accadendo nell’uomo suggerisce un cauto ottimismo, gli esperti invitano a non perdere di vista quello che sta succedendo negli animali, dove il virus Sars-CoV-2 potrebbe trovare nuovi serbatoi e da lì tornare, magari in forma mutata, all’uomo. Anche gli Oceani avranno le aree protette, è il risultato dell’accordo storico all’Onu per il primo trattato internazionale a protezione dell’alto mare, quello che a oltre 200 miglia nautiche dalle coste esula dalle giurisdizioni nazionali e rappresenta i due terzi degli oceani, che rappresentano ecosistemi fondamentali per l’umanità.
Anche gli Oceani avranno le aree protette, è il risultato dell’accordo storico all’Onu per il primo trattato internazionale a protezione dell’alto mare, quello che a oltre 200 miglia nautiche dalle coste esula dalle giurisdizioni nazionali e rappresenta i due terzi degli oceani, che rappresentano ecosistemi fondamentali per l’umanità. Giunta (SIMeVeP): “Carne sicura. Basta cuocerla. I Medici Veterinari della Asl Foggia stanno controllando le macellerie locali: nessun caso di positività alla trichinosi tra i campioni esaminati”.
Giunta (SIMeVeP): “Carne sicura. Basta cuocerla. I Medici Veterinari della Asl Foggia stanno controllando le macellerie locali: nessun caso di positività alla trichinosi tra i campioni esaminati”.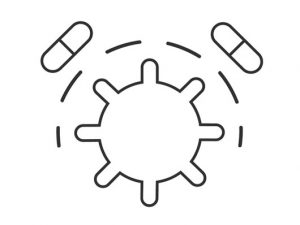 La resistenza dei batteri Salmonella e Campylobacter ad antimicrobici di uso comune viene osservata nell’uomo e negli animali di frequente, si rende noto in un rapporto pubblicato oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La resistenza simultanea ad antimicrobici di importanza critica per l’uomo è stata però rilevata generalmente a livelli bassi, eccezion fatta per alcuni tipi di Salmonella e Campylobacter coli in parecchi Paesi.
La resistenza dei batteri Salmonella e Campylobacter ad antimicrobici di uso comune viene osservata nell’uomo e negli animali di frequente, si rende noto in un rapporto pubblicato oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La resistenza simultanea ad antimicrobici di importanza critica per l’uomo è stata però rilevata generalmente a livelli bassi, eccezion fatta per alcuni tipi di Salmonella e Campylobacter coli in parecchi Paesi. Sorice (SIMeVeP): «La vaccinazione destinata agli animali è già pronta all’uso. Non escluso che, presto, per evitare il diffondersi di altri focolai, le autorità competenti decideranno di mettere a disposizioni le dosi necessarie per vaccinare gli animali presenti nei nostri allevamenti»
Sorice (SIMeVeP): «La vaccinazione destinata agli animali è già pronta all’uso. Non escluso che, presto, per evitare il diffondersi di altri focolai, le autorità competenti decideranno di mettere a disposizioni le dosi necessarie per vaccinare gli animali presenti nei nostri allevamenti» L’Ibis eremita (Geronticus eremita) è uno degli uccelli più rari al mondo; un tempo era diffuso in tutto il Medio Oriente, in Africa settentrionale ed Europa meridionale e centrale, ma da oltre 400 anni risulta scomparso dall’Europa e ne è rimasta una sola popolazione riproduttiva in Marocco, Algeria, Turchia e Siria.
L’Ibis eremita (Geronticus eremita) è uno degli uccelli più rari al mondo; un tempo era diffuso in tutto il Medio Oriente, in Africa settentrionale ed Europa meridionale e centrale, ma da oltre 400 anni risulta scomparso dall’Europa e ne è rimasta una sola popolazione riproduttiva in Marocco, Algeria, Turchia e Siria. Il Rotavirus gruppo A è una delle cause più comuni di diarrea del puledro. A partire da febbraio 2021, negli USA c’è stato un aumento della frequenza di casi gravi di diarrea emorragica nei puledri neonati. Le indagini hanno identificato come responsabile un nuovo gruppo di Rotavirus appartenente al gruppo B, molto simile ai rotavirus dello stesso gruppo precedentemente trovati nei ruminanti.
Il Rotavirus gruppo A è una delle cause più comuni di diarrea del puledro. A partire da febbraio 2021, negli USA c’è stato un aumento della frequenza di casi gravi di diarrea emorragica nei puledri neonati. Le indagini hanno identificato come responsabile un nuovo gruppo di Rotavirus appartenente al gruppo B, molto simile ai rotavirus dello stesso gruppo precedentemente trovati nei ruminanti. Negli ultimi dieci anni Mycoplasma gallisepticum ha cambiato la sua sensibilità verso molti dei farmaci più comunemente prescritti per il suo contenimento. Lo afferma uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto
Negli ultimi dieci anni Mycoplasma gallisepticum ha cambiato la sua sensibilità verso molti dei farmaci più comunemente prescritti per il suo contenimento. Lo afferma uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Per migliorare il benessere dei polli da carne e delle galline ovaiole d’allevamento, gli scienziati dell’EFSA raccomandano di evitare la pratica della mutilazione, la restrizione alimentare e l’uso di gabbie. Due pareri scientifici, pubblicati oggi, esprimono consigli sullo spazio, la densità degli animali, l’illuminazione, la polvere, il rumore, i rifiuti e strutture come le piattaforme sopraelevate.
Per migliorare il benessere dei polli da carne e delle galline ovaiole d’allevamento, gli scienziati dell’EFSA raccomandano di evitare la pratica della mutilazione, la restrizione alimentare e l’uso di gabbie. Due pareri scientifici, pubblicati oggi, esprimono consigli sullo spazio, la densità degli animali, l’illuminazione, la polvere, il rumore, i rifiuti e strutture come le piattaforme sopraelevate.