Allo studio un vaccino contro le malattie trasmesse da vettori
|
Al progetto, coordinato da Giovanna Barba-Spaeth del Pasteur di Parigi, lavorano gli esperti di un consorzio interdisciplinare costituito da 13 partner, di cui uno non europeo (Colombia), provenienti da 7 Paesi diversi. L’obiettivo è comprendere al meglio i meccanismi d’azione del vaccino più efficace contro i flavivirus: il vaccino per la febbre gialla 17D (YF17D). Yellow4FLAVI impiegherà questo vaccino per comprendere le basi molecolari della protezione immunitaria contro i flavivirus a lungo termine al fine di svelare gli aspetti critici dell’immunogenicità del vaccino, analizzando il ruolo strutturale delle particelle virali nella presentazione degli epitopi protettivi e studiando la risposta dell’ospite dalla sede di inoculo fino allo sviluppo della risposta immunitaria a lungo termine. Utilizzando la manipolazione genetica (reverse genetics) e il Cryo-EM (microscopia crioelettronica), oltre ad una pletora di approcci immunologici, verrà sviluppato un modello per la progettazione e il disegno di vaccini innovatici contro i flavivirus. Fonte: IZS Teramo |
 Ilaria Puglia, Marialuigia Caporale e il responsabile delle attività Alessio Lorusso, dell’IZS di Teramo, hanno preso parte al kick-off meeting del progetto europeo HORIZON
Ilaria Puglia, Marialuigia Caporale e il responsabile delle attività Alessio Lorusso, dell’IZS di Teramo, hanno preso parte al kick-off meeting del progetto europeo HORIZON  Un recente studio condotto dalla Commissione AGRI del Parlamento Europeo (2023) dal titolo “The dependency of the EU’s food system on input and their sources” (La dipendenza del sistema alimentare dell’UE dai fattori di produzione e dalle loro fonti) cita la necessità di rivedere diversi traguardi/obiettivi della F2F sulla base del feedback generale dei portatori di interessi (
Un recente studio condotto dalla Commissione AGRI del Parlamento Europeo (2023) dal titolo “The dependency of the EU’s food system on input and their sources” (La dipendenza del sistema alimentare dell’UE dai fattori di produzione e dalle loro fonti) cita la necessità di rivedere diversi traguardi/obiettivi della F2F sulla base del feedback generale dei portatori di interessi ( La disponibilità di risorsa idrica nell’anno 2023 conferma il trend negativo registrato da diversi anni in Italia, anche se come mostrato dalle stime del BIGBANG (il modello idrologico nazionale realizzato dall’ISPRA) può considerarsi un anno in ripresa rispetto al 2022.
La disponibilità di risorsa idrica nell’anno 2023 conferma il trend negativo registrato da diversi anni in Italia, anche se come mostrato dalle stime del BIGBANG (il modello idrologico nazionale realizzato dall’ISPRA) può considerarsi un anno in ripresa rispetto al 2022.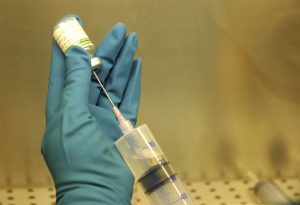
 In un rapporto pubblicato oggi, l’Ecdc delinea le principali considerazioni strategiche e operative per informare la pianificazione della preparazione alla progettazione e all’attuazione di misure sanitarie e sociali pubbliche (PHSM) nell’UE/SEE per le emergenze sanitarie e le pandemie.
In un rapporto pubblicato oggi, l’Ecdc delinea le principali considerazioni strategiche e operative per informare la pianificazione della preparazione alla progettazione e all’attuazione di misure sanitarie e sociali pubbliche (PHSM) nell’UE/SEE per le emergenze sanitarie e le pandemie. Una nuova pandemia? Arriverà. Non si sa quando, ma arriverà. La Storia lo insegna, l’Oms (l’Organizzazione mondiale della sanità) manda un messaggio globale parlando di malattia X e Ilaria Capua, virologa di fama mondiale, sette anni negli Stati Uniti dove ha diretto lo One Health Center in Florida e ora alla John Hopkins University di Bologna, lo conferma.
Una nuova pandemia? Arriverà. Non si sa quando, ma arriverà. La Storia lo insegna, l’Oms (l’Organizzazione mondiale della sanità) manda un messaggio globale parlando di malattia X e Ilaria Capua, virologa di fama mondiale, sette anni negli Stati Uniti dove ha diretto lo One Health Center in Florida e ora alla John Hopkins University di Bologna, lo conferma. L’Assemblea dei Soci della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva è convocata il giorno 11 aprile 2024 alle ore 06.30 in prima convocazione e il giorno 11 aprile 2024 alle ore 16.00 in seconda convocazione e si svolgerà presso la sede della SIMeVeP in Via Nizza 11 a Roma, per gli adempimenti statutari e l’analisi della programmazione delle attività SIMeVeP.
L’Assemblea dei Soci della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva è convocata il giorno 11 aprile 2024 alle ore 06.30 in prima convocazione e il giorno 11 aprile 2024 alle ore 16.00 in seconda convocazione e si svolgerà presso la sede della SIMeVeP in Via Nizza 11 a Roma, per gli adempimenti statutari e l’analisi della programmazione delle attività SIMeVeP. Per contrastare le frodi commerciali nel mercato dei mieli monofloreali, ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) hanno messo a punto una metodica di laboratorio sperimentale in grado di identificare in modo rapido ed economico l’origine botanica di un miele.
Per contrastare le frodi commerciali nel mercato dei mieli monofloreali, ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) hanno messo a punto una metodica di laboratorio sperimentale in grado di identificare in modo rapido ed economico l’origine botanica di un miele.
 Un nido di Vespa velutina è stato ritrovato in provincia di Firenze, nel comune di San Casciano Val di Pesa, sulle colline del Chianti fiorentino.
Un nido di Vespa velutina è stato ritrovato in provincia di Firenze, nel comune di San Casciano Val di Pesa, sulle colline del Chianti fiorentino.