Animali selvatici ed esotici: aggiornato l’elenco delle specie ammesse come animali da compagnia
 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 18 dicembre 2025, che modifica il decreto dell’11 ottobre 2022 relativo agli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale e autorizzati come animali da compagnia: il provvedimento aggiorna l’elenco delle specie ammesse, integrando le più recenti valutazioni tecniche e scientifiche. Tra le principali novità, il decreto esclude alcune specie considerate a rischio di estinzione o con potenziali rischi per la salute pubblica, mentre conferma altre specie la cui detenzione è ritenuta sicura e sostenibile; l’obiettivo è garantire un equilibrio tra la possibilità di possedere animali esotici come compagni e la tutela della biodiversità nazionale.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 18 dicembre 2025, che modifica il decreto dell’11 ottobre 2022 relativo agli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale e autorizzati come animali da compagnia: il provvedimento aggiorna l’elenco delle specie ammesse, integrando le più recenti valutazioni tecniche e scientifiche. Tra le principali novità, il decreto esclude alcune specie considerate a rischio di estinzione o con potenziali rischi per la salute pubblica, mentre conferma altre specie la cui detenzione è ritenuta sicura e sostenibile; l’obiettivo è garantire un equilibrio tra la possibilità di possedere animali esotici come compagni e la tutela della biodiversità nazionale.
Le valutazioni sono state effettuate dall’ISPRA in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, considerando diversi criteri: l’impatto sulla fauna selvatica, la probabilità che le specie possano stabilizzarsi nel territorio nazionale e la sicurezza sanitaria per l’uomo. Questa revisione tecnica è prevista dalla normativa vigente, che stabilisce aggiornamenti periodici per evitare rischi ecologici e sanitari. Il decreto evidenzia inoltre l’importanza di rispettare la normativa internazionale sulla protezione della fauna, in particolare le convenzioni internazionali per le specie a rischio, come quelle inserite nelle liste della IUCN Red List: alcune specie escluse sono state classificate come “vulnerable” o “endangered”, mentre altre sono state scartate per rischi sanitari o ecologici.
Fonte: AISA
 Sono state pubblicate con Decreto del Capo del Dipartimento le “Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali” rivolte alle Componenti e alle Strutture Operative del Servizio Nazionale interessate dal tema.
Sono state pubblicate con Decreto del Capo del Dipartimento le “Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali” rivolte alle Componenti e alle Strutture Operative del Servizio Nazionale interessate dal tema. Il contributo che pubblichiamo oggi, a firma di Maurizio Ferri (Coordinatore scientifico SIMeVeP), accende i riflettori su una metamorfosi preoccupante in atto nelle istituzioni europee. Sotto il vessillo della cosiddetta Agenda di Semplificazione e del Pacchetto Omnibus 2025 della Commissione, si sta consumando un passaggio critico che rischia di vedere la società civile e la sanità pubblica relegate in secondo piano rispetto alle logiche di riduzione dei costi per le imprese declamate nei nuovi provvedimenti. Riteniamo vitale seguire questo sviluppo normativo per alcuni elementi richiamati nel documento, in primis il pericolo che le decisioni tecniche vengano sottratte al rigore scientifico per favorire procedure più snelle ma meno sicure. Come garanti della salute secondo l’approccio One Health, i medici veterinari non possono restare spettatori di una riforma che incide sulla trasparenza e sulla qualità dei controlli.
Il contributo che pubblichiamo oggi, a firma di Maurizio Ferri (Coordinatore scientifico SIMeVeP), accende i riflettori su una metamorfosi preoccupante in atto nelle istituzioni europee. Sotto il vessillo della cosiddetta Agenda di Semplificazione e del Pacchetto Omnibus 2025 della Commissione, si sta consumando un passaggio critico che rischia di vedere la società civile e la sanità pubblica relegate in secondo piano rispetto alle logiche di riduzione dei costi per le imprese declamate nei nuovi provvedimenti. Riteniamo vitale seguire questo sviluppo normativo per alcuni elementi richiamati nel documento, in primis il pericolo che le decisioni tecniche vengano sottratte al rigore scientifico per favorire procedure più snelle ma meno sicure. Come garanti della salute secondo l’approccio One Health, i medici veterinari non possono restare spettatori di una riforma che incide sulla trasparenza e sulla qualità dei controlli.


 Il rapporto annuale dell’EFSA sui residui di farmaci veterinari negli animali vivi e nei prodotti di origine animale evidenzia anche nel 2024 un’elevata conformità ai limiti di legge.
Il rapporto annuale dell’EFSA sui residui di farmaci veterinari negli animali vivi e nei prodotti di origine animale evidenzia anche nel 2024 un’elevata conformità ai limiti di legge. La Commissione europea ha chiesto all’EFSA di condurre un sondaggio in tutta l’UE, prima e dopo che alcuni Paesi aggiornassero le proprie raccomandazioni sulla frequenza del consumo di pesce e frutti di mare che possono contenere tracce di mercurio.
La Commissione europea ha chiesto all’EFSA di condurre un sondaggio in tutta l’UE, prima e dopo che alcuni Paesi aggiornassero le proprie raccomandazioni sulla frequenza del consumo di pesce e frutti di mare che possono contenere tracce di mercurio.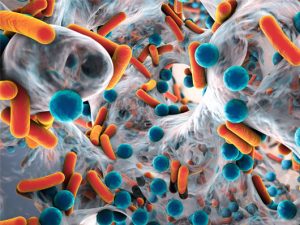 L’eccellenza della sanità veterinaria italiana al servizio della salute pubblica globale: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) sono stati ufficialmente designati Centro di Referenza FAO per la riduzione degli antimicrobici nelle aziende agricole per la trasformazione sostenibile dei sistemi agroalimentari (RENOFARM – Reduce the Need for Antimicrobials on Farms for Sustainable Agrifood Systems Transformation).
L’eccellenza della sanità veterinaria italiana al servizio della salute pubblica globale: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) sono stati ufficialmente designati Centro di Referenza FAO per la riduzione degli antimicrobici nelle aziende agricole per la trasformazione sostenibile dei sistemi agroalimentari (RENOFARM – Reduce the Need for Antimicrobials on Farms for Sustainable Agrifood Systems Transformation). Si terrà il 5 e 6 marzo p.v. il corso dal titolo “IL LUPO TRA CONVIVENZA, TERRITORIO E GESTIONE, i ruoli del Medico Veterinario pubblico e degli altri enti nella verifica dei danni da fauna selvatica tra aspetti istituzionali e medico legali ”. Il corso, patrocinato dalla SIMeVeP, ha ottenuto 23 crediti.
Si terrà il 5 e 6 marzo p.v. il corso dal titolo “IL LUPO TRA CONVIVENZA, TERRITORIO E GESTIONE, i ruoli del Medico Veterinario pubblico e degli altri enti nella verifica dei danni da fauna selvatica tra aspetti istituzionali e medico legali ”. Il corso, patrocinato dalla SIMeVeP, ha ottenuto 23 crediti.